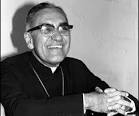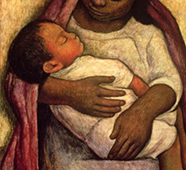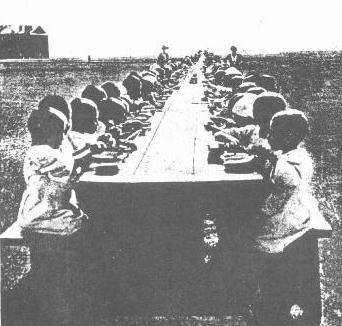Un fiume di acqua in piena per irrigare la speranza di cui abbiamo bisogno per crescere.
Cari amici di Giovanibarnabiti.it questo è il segno della lunga chiacchierata con padre Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo, Caivano, alle porte di Napoli: corruzione, legalità, fede, carità e speranza.
Se non sono indiscreto una prima domanda personale: chi è don Maurizio Patriciello?
Don Maurizio, anzi padre Maurizio come preferisco farmi chiamare perché don è il titolo dei camorristi, è un sacerdote della chiesa cattolica, un uomo che da adolescente si era allontanato dalla Chiesa, sbattendo le porte. Poi un giorno per un incontro fortuito con un francescano rinnovato, a cui ho dato un passaggio in auto, è nato un ritorno alla chiesa cattolica e un desiderio di conoscere di più la parola di Dio. Ho cominciato a studiare teologia da laico, quindi ho lasciato il mio lavoro perché mi è sembrato naturale entrare in seminario. Il desiderio di servire Dio con tutto me stesso; il ritorno alla Chiesa, la riscoperta della fede, è stato un tutt’uno.
Diventato prete sono arrivato qui a Caivano, alle porte di Napoli, in questo quartiere costruito per dare spazio ai terremotati del 1980.
Parlando con i giovani, tanti di quelli che io frequento ormai da anni, riscontro molto scoraggiamento, specialmente qui a Napoli, anche in chi non ha grossi problemi economici.
Questo è un quartiere molto povero e i problemi qui ci sono! Oggi è il primo maggio: come può festeggiarlo questa gente? Quanto farebbe bene del lavoro qui, in questo quartiere in cui passa -la droga per tutto il Sud Italia!
Però so che i giovani di oggi, anche senza problemi economici, vivono un disagio. Il mondo di oggi è cambiato: in pochi anni è successo quanto prima avrebbe richiesto 500 anni; un cambiamento repentino a cui non siamo preparati. I giovani di oggi nascono come se tutto fosse normale, ma non è normale niente! Come se tutto fosse presente!
La comunicazione è cambiata, così la famiglia che non ha più spazio per l’educazione.
Sapranno i nostri giovani gestire questa quantità di informazione, immagini, pensieri diversi… arrivando sempre a una conclusione ponderata, matura? Non so, non so!
La gestione dell’informazione è sicuramente complessa; poco fa abbiamo accennato alla droga, eppure oggi non si parla più di droga o sbaglio?
Non sbagli. Lo scorso inverno ero a parlare a Caserta, non vedevo la gente causa l’illuminazione. Mi sono presentato: buona sera, sono padre Maurizio, parroco a Caivano, parco Verde. Ci vedo poco, ma ci sento bene e mi sono reso conto di farfugliamenti dell’uditorio. Mi sono fermato qualche minuto quindi ho ribattuto: si, sono parroco al Parco Verde, dove si vende la droga, ma sappiate che quella droga lì si vende, ma sono i vostri figli di Caserta che la comprano! A quel punto il silenzio è stato assoluto.
Il discorso è grave e non se ne parla.
La droga ci porta poi alla questione della legalità, che non è un problema solo di questa terra, ma di tutta Italia.
Per la verità sono stanco di sentire parlare di legalità. La gente ha un’idea sbagliata di legalità. Legalità è un patto tra cittadino e stato, tra diritti e doveri. Si parla troppo di illegalità. Forse al Sud è più visibile, ma tra Expo, Mose, Mafiacapitale….
Raffaele Cantone ha detto che tra un camorrista e un corrotto è preferibile un camorrista perché si vede, mentre il corrotto è nascosto! È vero. Il problema grave di oggi è la corruzione. La camorra non è un sistema a parte, è nella politica, nell’industria: vedi la difficoltà di far passere delle leggi, di risolvere il problema dei rifiuti tossici.
Ai miei giovani, alla mia gente dico che la camorra è un mezzo problema! La camorra ha fatto da spalla alla finanza, non voglio giustificarla (i camorristi non amano nessuno, hanno una puzza che ha rovinato questa terra!) però i grandi affari dei rifiuti hanno riguardato tutti: politici, industriali, camorristi!
Ti sembra giusto che dovessi andare io a Strasburgo, al Quirinale, a Montecitorio per parlare della situazione di questa terra? Della disperazione di questa gente?
Carmine Schiavone, che ho incontrato in carcere, aveva già detto queste cose dal 1997! Quando poi i nostri giovani deputati hanno preteso la desecretazione di queste informazioni si scoprì che Carmine Schiavone aveva ragione. Perché tanto silenzio per tanti anni?
Come possiamo aiutare i giovani a recuperare questo patto con lo Stato, con la legalità?
Ieri è venuta una donna a chiedere come evitare di andare ancora da Loro per far mangiare i propri bambini? Loro sono gli usurai, ma questa donna deve far mangiare i suoi bambini, non gli basta un’offerta del parroco.
Quale il male minore per questa donna? Per chi pur volendo uscire dalla galera non trova lavoro? Che deve fare questa donna? Veder morire un figlio o rubare per dare da mangiare a suo figlio? So che rasento l’eresia, ma cosa deve fare un uomo in queste condizioni? Come fare per comprare un litro di latte? Far morire un figlio o …
Riusciremo a sconfiggere la camorra se non sconfiggeremo questa situazione?
Hai letto che oggi tanti titolari di aziende sono stati arrestati perché mantenevano dipendenti in nero. Ma anche un imprenditore – ne ho parlato con il ministro del Lavoro, dell’Ambiente, con il presidente Napolitano – come può continuare a lavorare con queste leggi?
Questa è la terra dei fuochi, ma cosa brucia? Gli scarti delle industrie del Nord Italia, d’Europa, interrati a metri di profondità così che “non colpiscono” il terreno in superficie, ma la falda acquifera! Poi c’è il problema dell’aria infestata da diossina dei roghi tossici… questa è una terra martoriata ieri e ancora oggi per tante produzioni illegali.
Certo si potrebbe fermare il lavoro nero, ma ci sarebbe una rivoluzione perché come potrebbero continuare a mangiare migliaia di famiglie? Lo Stato dovrebbe essere capace di trovare delle prospettive, delle opportunità diverse e legali per chi dà lavoro e per chi lo riceve!
Ma lo Stato vuole fare la sua parte?
Per anni non ho mai parlato male delle Istituzioni, ho sempre avuto rispetto ma da quando sono prete ho toccato con mano un’altra realtà: lo Stato non c’è! Lo stato non vuole esserci!
Abbiamo giovani fuggiti all’estero, giovani che non escono più di casa per vergogna di non avere un lavoro…
Lo Stato non ha la bacchetta magica, ma la cosa pubblica grida vendetta; siamo di fronte a ladri di speranza pubblici ufficiali! La gente non sa più con chi parlare.
Ma la gente non riesce a convincersi di poter fare qualche cosa, torna a votare quelli di prima?
Il papa ci invita a impegnarci in politica, ma manca una sensibilità verso il bene comune.
Però anche noi Chiesa abbiamo dei torti, per esempio una incapacità di continuare a fare scuola di politica, dalle piccole alle grandi cose? Eppure tante sono le persone che vogliono ancora fare qualche cosa.
Si. Abbiamo tante persone che si danno da fare, di volontari. Il volontario fa bene il suo lavoro e poi gratuitamente, perché ha un cuore grande, fa dell’altro, dell’in più! È una parte bella dell’Italia.
Ciò che non funziona è il dare del lavoro.
Come posso dire alla gente: prega, prega il rosario, in queste disperazioni dove veramente non si mangia!
Noi preti dobbiamo essere di pungolo, più che degli assistenti sociali, pungolare lo Stato a fare il proprio dovere; essere coscienza critica dello Stato.
Papa Francesco esorta i giovani a non lasciarsi rubare la speranza: come aiutare i giovani in ciò?
Il rosario è fondamentale per non perdere la speranza, poi celebreremo la messa per non perdere la speranza, poi ci incontreremo per non perdere la speranza, poi piccoli gesti per non perdere la speranza. Gesti piccoli, boccate di ossigeno che sono fondamentali per non perdere la speranza, poi arriveranno altri grandi gesti.
Noi siamo preti, dobbiamo fare la volontà di Dio; certo certi preti rovinano la Chiesa, ma noi puntiamo alla santità guidati dalla Divina Provvidenza in questo momento critico e difficile. Teniamo la chiesa aperta, sempre, per tutti!
Grazie di cuore. Buon lavoro. La benedizione di Dio resti sul suo capo.