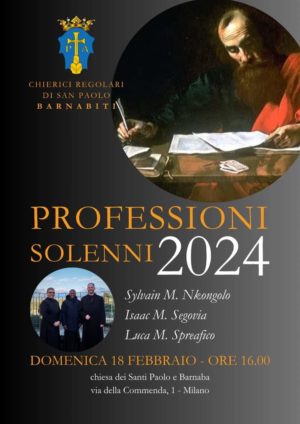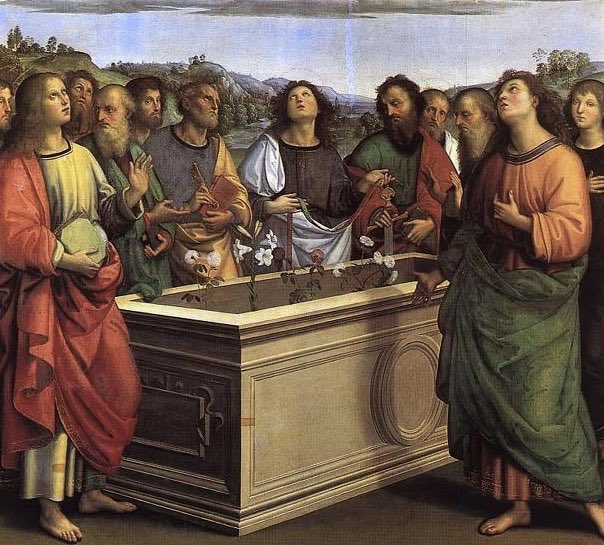“Adolescenti sani!”: questo il titolo dell’articolo editoriale con il quale avevamo aperto il primo numero del 2025 della nostra rivista cartacea. Un articolo che parla di giovani, pandemia e cambiamenti, ma che principalmente interroga gli adulti e chi dei giovani si occupa.
Abbiamo quindi chiesto ad alcuni di questi “giovani” di darci dei brevi commenti su questo articolo, che riportiamo in seguito.
Valeria partendo dalla sua esperienza personale, ci racconta di come non solo i giovani sono cambiati durante il covid, ma anche gli adulti, e si sofferma sull’importanza di un ascolto sincero dei giovani, e scrive:
«Leggendo queste parole, mi sono sentita profondamente coinvolta, perché quando è scoppiata la pandemia avevo soltanto 11 anni. Mi trovavo in quel periodo di passaggio tra l’essere bambina e diventare una ragazza, proprio all’inizio dell’adolescenza. Un momento delicato, in cui tutto inizia a cambiare: il corpo, le emozioni, le relazioni. Ma invece di vivere queste trasformazioni con naturalezza, tutto si è bloccato. Ognuno di noi ha vissuto questo trauma collettivo in modo diverso, sfogando alla fine di esso reazioni differenti.
Ho notato anche io, come viene detto nell’articolo, un cambiamento repentino nei ragazzi poco più grandi o poco più giovani di me, i quali sono diventati molto più agitati, poco consapevoli delle loro azioni e riscontrano gravi difficoltà nel socializzare. É ovvio che le ripercussioni ci sono state anche sugli adulti, che sono diventati sempre più egoisti e impazienti, come se dovessero recuperare il tempo perso durante il lockdown.
Io ritengo, come anche affermato nel testo, che sia fondamentale che gli adulti aiutino noi giovani a ritrovare sé stessi, ad essere ascoltati e capiti anche se ciò potrebbe essere visto come una perdita di tempo a causa degli atteggiamenti discostanti o provocatori che a volte mostriamo. Secondo me, essendo una loro coetanea, penso sia l’unico modo per portare sulla retta via ragazzi agitati, sempre con il telefono tra le mani e con la testa altrove, poiché l’unica cosa di cui abbiamo bisogno, in realtà, è un punto di riferimento stabile, adulti capaci di ascoltarci davvero, con pazienza, senza volerci subito correggere o “aggiustare”. Dunque, come conclude l’articolo, la vera sfida non è riportarci in chiesa o farci seguire regole, ma aiutarci a sentire che c’è qualcuno che ci chiama per nome, che crede in noi e nel nostro futuro e non ci consideri come dei “malati” o delle persone da “aggiustare”.»
Anche Giacomo ci racconta della sua esperienza personale durante la pandemia e di come, secondo lui, la pandemia abbia influito sui comportamenti dei giovani:
«Leggere questo articolo mi ha fatto tornare alla mente tante cose a cui spesso cerco di non pensare. Quando è iniziata la pandemia avevo 11 anni, ero alle medie, e sinceramente non avevo capito subito cosa stava succedendo. All’inizio sembrava quasi una vacanza, niente scuola, tutto chiuso, giornate infinite a casa. Ma poi è diventato pesante. Le lezioni online, la solitudine, la noia, il senso di smarrimento… sono cose che non si dimenticano.
L’articolo mi ha colpito perché, per una volta, qualcuno ha saputo descrivere bene quello che tanti della mia generazione hanno vissuto e stanno ancora vivendo. Non si tratta solo di “pigrizia” o “mancanza di voglia”, come spesso ci viene detto. È che ci siamo ritrovati a crescere in un momento strano, dove tutto era sospeso, dove le relazioni erano dietro a uno schermo e il futuro sembrava lontanissimo, quasi finto.
Ora ho 17 anni e a volte mi sento ancora un po’ perso. È come se ci mancassero dei pezzi, come se fossimo cresciuti in fretta ma senza tutti gli strumenti. Ed è frustrante sentirsi dire “ormai è passato”, come se tutto dovesse tornare normale automaticamente. Ma non è così semplice.
Quello che dice l’articolo sulla pazienza e sulla presenza degli adulti mi sembra verissimo. Non abbiamo bisogno di essere giudicati o corretti in continuazione. Abbiamo bisogno che qualcuno ci stia vicino davvero, che provi a capirci senza pretendere subito risultati o cambiamenti. A volte basta poco: uno sguardo, una domanda sincera, qualcuno che ascolta senza interrompere.
Mi ha fatto bene leggere queste parole, perché mi sono sentito capito. E penso che anche molti miei coetanei si ritroverebbero in questo. Non vogliamo fare le vittime, ma neanche essere trattati come se fossimo sbagliati o rotti. Abbiamo solo bisogno di tempo, e di qualcuno che creda in noi, anche quando facciamo fatica a crederci da soli.»
Sarah (adulta, con una esperienza di educatrice e di lavoro) ci spiega quali, secondo lei, sono le origini di questi cambiamenti dei comportamenti, legate ai social e all’iper performatività a cui i bambini sono sempre più sottoposti, e di come questi processi si siano intrecciato con la pandemia:
“Effettivamente sono d’accordo con te sul fatto che non si dedichi abbastanza “tempo” ai giovani. Da bambini imparano che devono fare mille attività organizzate e vedono i genitori giusto la sera prima di andare a dormire. attività in cui devono eccellere, in cui sono sempre considerati i migliori. Secondo me sono una generazione non abituata ai no che si è trovata ad affrontare un periodo (la pandemia) che li ha posti davanti ad un grandissimo no.
Una generazione (credo colpa anche dei social e dei ritmi frenetici che essi impongono) che non sa soffermarsi sulle cose, che fatica ad andare in profondità. Io personalmente avevo trovato negli scout un posto dove ti chiedono di fermarti, di capire chi sei non solo come essere unico e staccato dalla realtà ma soprattutto in relazione con l’altro e la comunità che ti circonda. ricordo che mi aveva molto aiutato e ha decisamente influenzato le mie scelte di vita future
Ovviamente sto molto generalizzando, sicuramente ci sono delle eccezioni, ma in un’epoca in cui vince chi grida più forte (il tutto amplificato da internet), individui che già attraversano un periodo difficile (quello dell’adolescenza) fanno sicuramente ancora più fatica.
E per concludere, durante la pandemia abbiamo estremamente sottovalutato l’impatto psicologico che essa ha avuto su certe fasce della popolazione (adolescenti e studenti in generale e anziani i primis, persone più povere che non avevano accesso a tutti gli strumenti informatici necessari a continuare a lavorare e studiare o che semplicemente vivevano in spazi ristretti in famiglie numerose).
Vincenzo sottolinea di nuovo, l’importanza dell’ascolto e della pazienza nel rapporto con i giovani, fondamentali per riconoscerli nelle loro forze e fragilità:
«Questo testo è molto toccante, perché parla in modo sincero delle difficoltà che i giovani stanno vivendo dopo la pandemia. Fa riflettere su quanto il COVID abbia lasciato segni profondi, anche se spesso invisibili. L’autore dice che oggi educare non significa solo dare regole, ma soprattutto ascoltare, stare vicino e avere tanta pazienza. I ragazzi hanno voglia di stare insieme, ma fanno fatica a costruire legami veri e duraturi. Si sente il bisogno di dare loro fiducia e tempo, anche solo per stare con loro senza fare nulla. Il testo invita a guardarli negli occhi, a riconoscerli per quello che sono, con le loro forze e le loro fragilità. Non serve riportarli solo in chiesa, ma aiutarli a scoprire chi sono e quale può essere il loro posto nel mondo. È un invito a seminare amore, accoglienza e speranza, anche se i risultati arriveranno piano piano.»
Anche Gianluigi, infine, sottolinea la necessità di un aiuto concreto nel riconoscere una chiamata alla vita vera:
«Questo articolo interpella fortemente chiunque abbia a che fare con i giovani (genitori, educatori, insegnanti, animatori). Il vero messaggio, però, è rivolto anche al mondo adulto nel suo insieme: non si può educare senza mettere in gioco sé stessi, senza rallentare, senza scegliere di esserci davvero.
La pandemia ci ha mostrato quanto fragile sia la nostra società, e quanto velocemente possiamo perdere l’essenziale. Ma ci ha anche mostrato che la relazione col prossimo è ciò che può farci ripartire.
Il messaggio finale è potente: più che riportarli in chiesa, aiutiamoli a riconoscere una chiamata. Che sia spirituale, personale, relazionale. In ogni caso, una chiamata alla vita vera.»
vocazione
Cocciuti nel seguire il vangelo
Milano, 25 gennaio, festa della Conversione di san Paolo; in questo giorno così importante per i Barnabiti, siamo a Milano comunità di san Barnaba per incontrare tre persone che il prossimo 18 febbraio diventeranno barnabiti per sempre. Sylvan, Luca, Isaac.
Sylvan (NKONGOLO Wa Mutombo di Kinshasa RDCongo), 33 anni.
La gioia è la parola che di più usa per parlarci di sé. La gioia invocata per lui dai suoi genitori prima di entrare in seminario a 2000km di distanza da loro!
La gioia di sentirsi per questo mondo, che spesso oggi sembra lontano dai valor cristiani, utile e significativo nonostante le proprie imperfezioni.
La gioia di conoscere sant’Antonio Maria Zaccaria che si fida molto di me, che mi incita a crescere continuamente nel fare il bene, nel superare la tiepidezza.
Per questo chiedo ai giovani di non avere paura di ma di rischiare la vita non solo con le parole, ma con azioni concrete. Mentre agli anziani chiedo di avere fiducia in noi e sostenerci.
Un po’ diversa la storia di Luca (Spreafico di Eupilio), età 37, laureato in scienze agrarie.
Infanzia e giovinezza in oratorio dove ha incontrato i Barnabiti, il loro impegno per i giovani e la fraternità e il costante buon umore di p. Albino Dutto.
Per questo anche in futuro vorrebbe trovare il medesimo clima sereno e fraterno, peraltro già vissuto durante l’anno di noviziato in Chile.
E se hai barnabiti anziani chiede di essere meno cocciuti ed egocentrici! ai giovani dice di prendere sul serio la vita di fede con la sua bellezza e provocazioni.
Infine, Don Isaac (Segovia, Choré/Paraguay), 40 anni, laureato in diritto canonico.
E una vocazione adulta, per questo ha avuto modo di girare diverse comunità barnabitiche del Brasile dal Sud al Nord, scoprendo i differenti modi di vivere la fede. «Prima della vocazione ho lavorato nel Congresso nazionale del Paraguay, quindi con i bambini di strada a Sao Paulo. In tutti questi giri, ma anche oggi, il ricordo che mi sostiene è la famiglia. Di questa nuova famiglia barnabitica invece voglio percepire continuamente il desiderio di una riforma continua: non siamo mai santi abbastanza. Per questo chiedo ai padri più anziani chiedo di stare insieme ai più giovani per illuminarli, per crescere con la loro storia viva da condividere. Infine, un desiderio: mi piacerebbe lavorare come barnabita nell’Università.»
Poche righe per tracciare il profilo di grandi storie di oggi per il futuro, radicato in una famiglia religiosa che proprio oggi (era il 18 febbraio 1533 a Bologna) festeggia il proprio compleanno. Quale regalo più bello che la professione solenne, cioè la scelta di seguire per sempre la strada del vangelo secondo la via tracciata da S. Antonio M. Zaccaria ?
Un ferragosto BarnabitiAPS
La festa di oggi, che la si chiami Ferragosto o dell’Assunta, ha diverse origini pagane e cristiane, senza nulla togliere all’una o all’altra radice.
Una festa è sempre una festa e questo è importante per il bene dell’uomo e della donna. Una festa serve per rigenerare il pensiero e l’anima e il corpo, per questo una festa quando è veramente una Festa è sempre religiosa, al di là che sia pagana o – nel nostro contesto – cristiana.
Forse che i cattolici hanno “imposto” questo evento della vita di Maria a questa festa di origine romane? O forse hanno semplicemente evidenziato il bisogno di luce e di bene che questa festa portava con sé e che il dogma dell’Assunzione non solo riecheggia, ma amplifica? Io credo di più a questa seconda versione, non perché cattolico, ma perché comunque la fede cristiana ha nel suo DNA la preoccupazione di esaltare il bisogno di luce, di vita, di eternità che ogni uomo porta con sé. In una società sempre più secolarizzata, cioè priva di riferimenti a Dio, dove per molti versi emerge il delirio di onnipotenza piuttosto che il bisogno di eternità è veramente importante recuperarne il senso. In una società dove spesso anche i cristiani sono più inclini all’intimismo piuttosto che alla testimonianza è importante recuperare il valore anche di questa festa.
Che Maria non debba subire la corruzione del corpo dopo la morte non è un manga (?), una burla o una boutade pubblicitaria è la risposta al bisogno di mistero e di senso che ogni uomo e donna hanno.
Se ci pensiamo bene facciamo di tutto per il nostro bene, per il bene del nostro corpo; se ci pensiamo bene facciamo di tutto per fermare il disfacimento del corpo fino a praticare l’eutanasia. La festa dell’Assunzione di Maria al cielo continua non solo il bisogno di bene che già l’Imperatore Augusto indisse con la Feriae Augustales, ma lo risolve affermando che il bene per eccellenza è quello dopo la morte. Ma non un bene del Dopo, bensì un bene che sollecita, sostiene, guida e coltiva il bene del qui e ora. Il cristiano non crede al Paradiso per fuggire dal terreno, bensì per credere meglio e di più nel presente.
«Quando Nietzsche si pone questioni sul senso di questa festa, scopre, indagando l’incantesimo del dionisiaco, che in essa si celebra la riconciliazione tra la natura e il suo figlio perduto, l’uomo. Scrive ne La nascita della tragedia che diventa il tempo in cui si coglie la luce della dimensione aurorale del mondo, che si rinnova in virtù dell’incantamento della forza di liberazione che lo percorre» (IlSole24ore, 15 08 2021, III).
Nella storia semplice e fantastica di questa piccola e sconosciuta donna semita (meglio di qualsiasi anima giapponese) troviamo la risposta a quel bisogno della luce aurorale del mondo di incontrare l’uomo. In Maria però non c’è solo una eccelsa filosofia, bensì la storia concreta del Mistero di Dio che incontra e abbraccia il mistero dell’Uomo e della Donna.
A noi volontari zaccariani è chiesto di essere ancora più consapevoli del senso di tale festa dell’Assunzione di Maria al Cielo, non solo per recitare qualche Ave Maria in più (che fa sempre bene come direbbe il nostro SAMZ) bensì per testimoniare la vita di Dio tra la vita degli uomini.
Specialmente dopo che il recente Capitolo della neoprovincia Italiana ha riconosciuto e incentivato la nostra BarnabitiAPS abbiamo realmente bisogno di ri-conoscere e qualificare la nostra vocazione umana e cristiana.
Come Maria con la sua vita ha permesso alla vita di Dio di entrare nella vita degli uomini e delle donne, così a ognuno di noi è chiesto di continuare a coltivare questo mistero della Vita. Non è delirio di onnipotenza niciana, è risposta alla vocazione cristiana.
Chiudere o aprire?
4^ domenica del tempo di Pasqua
Questa quarta domenica di Pasqua è dedicata alla preghiera per le vocazioni alla vita cristiana e alla vita sacerdotale e consacrata in modo particolare, cioè a chiedere a Dio Padre il dono di nuovi pastori per il suo gregge.
Forse siamo ancora poco consapevoli della crisi vocazionale che stiamo attraversando, ma forse un po’ di più della crisi cristiana che stiamo attraversando. Capite che se manca la terra buona di una vita cristiana diventa più difficile seminare nuovi pastori, nuovi pescatori di uomini.
Questa crisi nasce però da una crisi generalizzata della vocazione alla vita: la vita è dono, ma noi ne abbiamo fatto un consumo a nostro esclusivo favore.
Prima ci sono io, poi gli altri, forse!
Il “noi” non è più la prima persona plurale, prima persona, è ormai la centesima persona indefinita. L’“io” è sempre il problema eterno dell’uomo, ma oggi di più (il populismo ne è la conseguenza principale).
I termini che Gesù usa nella seconda parte del brano giovanneo riguardano il cattivo uso del tempio, dell’area del tempio; sono i termini usati per cacciare i mercanti, gli ipocriti preoccupati del proprio “io”, del borsellino, piuttosto che del “noi” del popolo di Dio.
Questo brano di oggi segue la guarigione del “cieco nato”; Gesù continua a parlare ai farisei ciechi, ai discepoli definendosi pastore e, specificamente la “porta” da cui passare per la salvezza.
Io sono la porta che non si è chiusa nella propria divinità, ma si è aperta all’umanità. Io sono la porta non per far passare meglio ladri e assassini, ma per farvi conoscere la mia voce, per chiamarvi per nome, chiamarvi amici.
Quale voce vogliamo ascoltare? Quale porta vogliamo aprire?
La porta ha un valore simbolico e antropologico forte, specialmente oggi per non fare entrare il virus! La normalità ripetitiva dell’uscire di casa e del rientrarvi a piacimento oggi è messa in discussione. La porta può chiudere, ma anche aprire, serve per entrare ma anche per uscire.
La porta deve essere un limite che non imprigiona ma che è a servizio della libertà sia quando protegge l’intimità della persona all’interno, sia quando apre all’esterno. Immagine di chiusura e apertura, di intimità e relazione, di protezione e di esposizione, di inspirazione ed espirazione, la potenza antropologica del simbolo della porta viene applicata dall’evangelista Giovanni a Cristo stesso. Infatti, attraverso la porta che è Cristo stesso, si entra e si esce. Tutta la vita umana si riassume nei due atti fondamentali dell’entrare e dell’uscire: dalla nascita, l’uscita dal seno materno, all’uscire ed entrare in casa e negli spazi della vita, fino all’uscita definitiva con la morte. Il simbolo della porta applicata a Cristo indica dunque il compito del cristiano di vivere ricominciando sempre la sequela del Cristo, ovvero passare attraverso la porta che è Cristo. (Manicardi)
Mi chiedo e vi chiedo:
io che sono giovane, io che sono famiglia, io che sono compagna o compagno di una storia d’amore; Cristo è la porta che preserva la mia intimità, ma anche mi apre a Lui e all’altro?
Recentemente un prete ha scritto che il cristianesimo è ai minimi termini, tanto che no ci lasciano nemmeno aprire le chiese (è bene che sia così!); forse non si rende conto che ormai da tempo i cristiani stessi preferiscono altre porte per riparare o preservare li proprio ego.
Cristo è diventato la porta di servizio!
Cristo non è la porta di servizio, ma “la Porta” attraverso cui passare per diventare suoi amici e con lui continuare a costruire il regno di Dio.
Non dobbiamo avere paura di aprire, anzi, spalancare le porte a Cristo; non dobbiamo avere paura di indossare il vestito della festa, non il pigiama (come dicevano domenica scorsa) per accoglierlo; Cristo non cerca l’immunità di gregge, ma uomini e donne portatori del buon profumo di Cristo nostro pastore.
Cristo non ha avuto di prendere il nostro profumo – anche le nostre spuzze – di uomini e donne, perché noi possiamo prendere il profumo della sua amicizia da portare a questa umanità sofferente.
Per questo io e padre Antonio, nonostante le nostre spuzze, abbiamo accolto il dono del sacerdozio, anche su questo noi tutti cristiani dobbiamo riflettere e pregare se vogliamo che ancora si possa annunciare al mondo: Cristo è risorto, è veramente risorto!