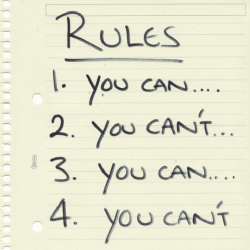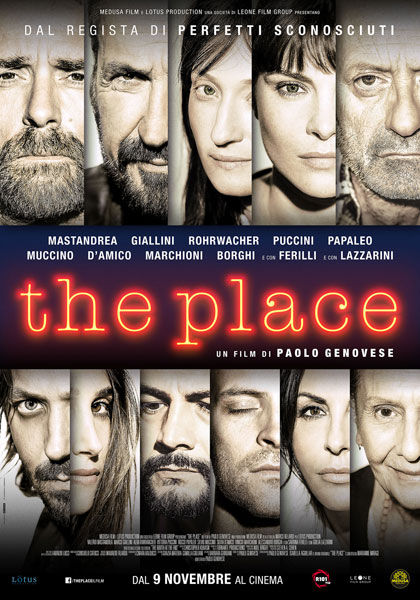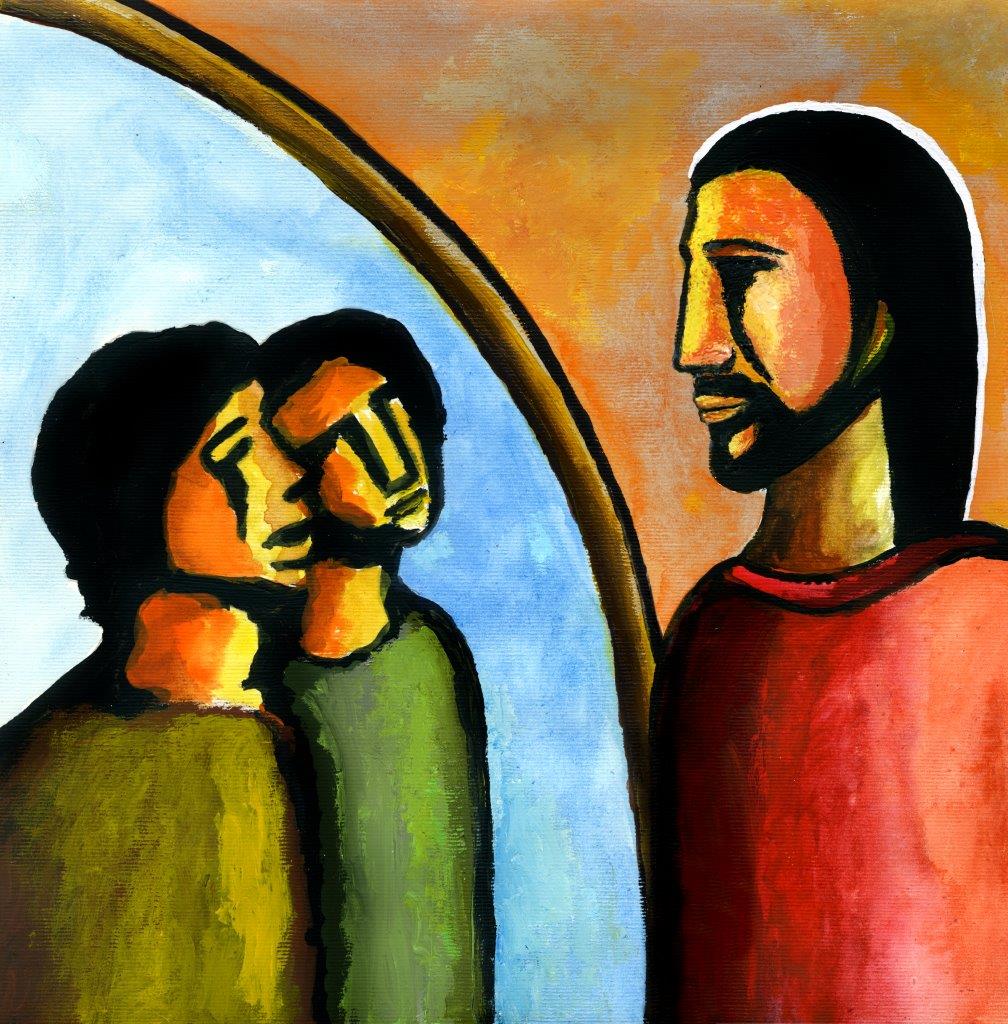Discorso di papa Francesco apertura pre-sinodo (19.03.2018)
Cari giovani, buongiorno!
Saluto tutti i 15340! Speriamo che domani siano di più in questo nostro interloquire per fare uscire quello che ognuno di voi e di noi abbiamo nel cuore. Parlare con coraggio. Senza vergogna, no. Qui la vergogna si lascia dietro la porta. Si parla con coraggio: quello che sento lo dico e se qualcuno si sente offeso, chiedo perdono e vado avanti. Voi sapete parlare così. Ma bisogna ascoltare con umiltà. Se parla quello che non mi piace, devo ascoltarlo di più, perché ognuno ha il diritto di essere ascoltato, come ognuno ha il diritto di parlare.
Grazie per aver accettato l’invito di venire qui. Alcuni di voi hanno dovuto fare un lungo viaggio. Altri, invece di andare a dormire – perché è ora di andare a dormire da loro – sono collegati con voi. Faranno la notte ascoltando. Venite da tante parti del mondo e portate con voi una grande varietà di popoli, culture e anche religioni: non siete tutti cattolici e cristiani, nemmeno tutti credenti, ma siete certamente tutti animati dal desiderio di dare il meglio di voi. E io non ho dubbi su questo. Saluto anche quelli che si collegheranno, e che lo già hanno fatto: grazie del vostro contributo!
Voglio ringraziare in modo speciale la Segreteria del Sinodo, il Cardinale Segretario, l’Arcivescovo Segretario e tutti, tutti quelli che lavorano nella Segreteria del Sinodo. Hanno lavorato fortemente per questo e hanno avuto una capacità di inventare cose e creatività molto grandi. Grazie tante, Cardinale Baldisseri, e a tutti i vostri collaboratori.
Siete invitati perché il vostro apporto è indispensabile. Abbiamo bisogno di voi per preparare il Sinodo che a ottobre riunirà i Vescovi sul tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. In tanti momenti della storia della Chiesa, così come in numerosi episodi biblici, Dio ha voluto parlare per mezzo dei più giovani: penso, ad esempio, a Samuele, a Davide e a Daniele. A me piace tanto la storia di Samuele, quando sente la voce di Dio. La Bibbia dice: “In quel tempo non c’era l’abitudine di sentire la voce di Dio. Era un popolo disorientato”. È stato un giovane ad aprire quella porta. Nei momenti difficili, il Signore fa andare avanti la storia con i giovani. Dicono la verità, non hanno vergogna. Non dico che sono “svergognati” ma non hanno vergogna e dicono la verità. E Davide da giovane incomincia con quel coraggio. Anche con i suoi peccati. Perché è interessante, tutti questi non sono nati santi, non sono nati giusti, modelli degli altri. Sono tutti uomini e donne peccatori e peccatrici, ma che hanno sentito il desiderio di fare qualcosa di buono, Dio li ha spinti e sono andati avanti. E questo è bellissimo. Noi possiamo pensare: “Queste cose sono per le persone giuste, per i preti e per le suore”. No, è per tutti. E voi giovani di più, perché avete tanta forza per dire le cose, per sentire le cose, per ridere, anche per piangere. Noi adulti tante volte, tante volte, abbiamo dimenticato la capacità di piangere, ci siamo abituati: “Il mondo è così… che si arrangino”. E andiamo avanti. Per questo vi esorto, per favore: siate coraggiosi in questi giorni, dite tutto quello che vi viene; e se sbagli, un altro ti correggerà. Ma avanti, con coraggio!
1. Troppo spesso si parla di giovani senza lasciarci interpellare da loro. Quando qualcuno vuole fare una campagna o qualcosa, ah, lode ai giovani!, non è così?, ma non permette che i giovani li interpellino. Lodare è un modo di accontentare la gente. Ma la gente non è sciocca o stupida. No, non lo è. La gente capisce. Soltanto gli scemi non capiscono. In spagnolo c’è un motto bellissimo che dice: “Loda lo scemo e lo vedrai lavorare”. Dare la pacca sulla spalla e lui sarà contento, perché è scemo, non se ne accorge. Ma voi non siete scemi! Anche le migliori analisi sul mondo giovanile, pur essendo utili – sono utili –, non sostituiscono la necessità dell’incontro faccia a faccia. Parlano della gioventù d’oggi. Cercate per curiosità in quanti articoli, quante conferenze si parla della gioventù di oggi. Vorrei dirvi una cosa: la gioventù non esiste! Esistono i giovani, storie, volti, sguardi, illusioni. Esistono i giovani. Parlare della gioventù è facile. Si fanno delle astrazioni, percentuali… No. La tua faccia, il tuo cuore, cosa dice? Interloquire, sentire i giovani. A volte, evidentemente, voi non siete, i giovani non sono il premio Nobel per la prudenza. No. A volte parlano “con lo schiaffo”. La vita è così, ma bisogna ascoltarli.
Qualcuno pensa che sarebbe più facile tenervi “a distanza di sicurezza”, così da non farsi provocare da voi. Ma non basta scambiarsi qualche messaggino o condividere foto simpatiche. I giovani vanno presi sul serio! Mi sembra che siamo circondati da una cultura che, se da una parte idolatra la giovinezza cercando di non farla passare mai, dall’altra esclude tanti giovani dall’essere protagonisti. È la filosofia del trucco. Le persone crescono e cercano di truccarsi per sembrare più giovani, ma i giovani non li lascia crescere. Questo è molto comune. Perché? Perché non si lascia che vengano interpellati. È importante. Spesso siete emarginati dalla vita pubblica ordinaria e vi trovate a mendicare occupazioni che non vi garantiscono un domani. Non so se questo succede in tutti i vostri Paesi, ma in tanti… Se non sbaglio il tasso di disoccupazione giovanile qui in Italia dai 25 anni in su è verso il 35%. In un altro Paese d’Europa, confinante con l’Italia, 47%. In un altro Paese d’Europa vicino all’Italia, più del 50%. Cosa fa un giovane che non trova lavoro? Si ammala – la depressione –, cade nelle dipendenze, si suicida – fa pensare: le statistiche di suicidio giovanile sono tutte truccate, tutte –, fa il ribelle – ma è un modo di suicidarsi – o prende l’aereo e va in una città che non voglio nominare e si arruola nell’Isis o in uno di questi movimenti guerriglieri. Almeno ha un senso da vivere e avrà uno stipendio mensile. E questo è un peccato sociale! La società è responsabile di questo. Ma io vorrei che foste voi a dire le cause, i perché, e non dire: “Neanch’io so bene il perché”. Come vivete voi questo dramma? Ci aiuterebbe tanto. Troppo spesso siete lasciati soli. Ma la verità è anche il fatto che voi siete costruttori di cultura, con il vostro stile e la vostra originalità. È un allontanamento relativo, perché voi siete capaci di costruire una cultura che forse non si vede, ma va avanti. Questo è uno spazio che noi vogliamo per sentire la vostra cultura, quella che voi state costruendo.
Nella Chiesa – sono convinto – non dev’essere così: chiudere la porta, non sentire. Il Vangelo ce lo chiede: il suo messaggio di prossimità invita a incontrarci e confrontarci, ad accoglierci e amarci sul serio, a camminare insieme e condividere senza paura. E questa Riunione pre-sinodale vuol essere segno di qualcosa di grande: la volontà della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso. E questo non per fare politica. Non per un’artificiale “giovano-filia”, no, ma perché abbiamo bisogno di capire meglio quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo. Se mancate voi, ci manca parte dell’accesso a Dio.
2. Il prossimo Sinodo si propone in particolare di sviluppare le condizioni perché i giovani siano accompagnati con passione e competenza nel discernimento vocazionale, cioè nel «riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza» (Documento preparatorio, Introduzione). Tutti noi abbiamo questa chiamata. Voi, nella fase iniziale, siete giovani. Questa è la certezza di fondo: Dio ama ciascuno e a ciascuno rivolge personalmente una chiamata. È un dono che, quando lo si scopre, riempie di gioia (cfr Mt 13,44-46). Siatene certi: Dio ha fiducia in voi, vi ama e vi chiama. E da parte sua non verrà meno, perché è fedele e crede davvero in voi. Dio è fedele. Per i credenti dico: “Dio è fedele”. Vi rivolge la domanda che un giorno fece ai primi discepoli: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38). Anch’io, in questo momento, vi rivolgo la domanda, a ognuno di voi: “Cosa cerchi? Tu, cosa cerchi nella tua vita?”. Dillo, ci farà bene ascoltarlo. Dillo. Di questo abbiamo bisogno: di sentire il vostro cammino nella vita. Cosa cerchi? Vi invita a condividere la ricerca della vita con Lui, a camminare insieme. E noi, desideriamo fare lo stesso, perché non possiamo che condividere con entusiasmo la ricerca della vera gioia di ciascuno; e non possiamo tenere solo per noi Chi ci ha cambiato la vita: Gesù. I vostri coetanei e i vostri amici, anche senza saperlo, aspettano anche loro una chiamata di salvezza.
3. Il prossimo Sinodo sarà anche un appello rivolto alla Chiesa, perché riscopra un rinnovato dinamismo giovanile. Ho potuto leggere alcune e-mail del questionario messo in rete dalla Segreteria del Sinodo e mi ha colpito l’appello lanciato da diversi giovani, che chiedono agli adulti di stare loro vicini e di aiutarli nelle scelte importanti. Una ragazza ha osservato che ai giovani mancano punti di riferimento e che nessuno li sprona ad attivare le risorse che hanno. Poi, accanto agli aspetti positivi del mondo giovanile, ha sottolineato i pericoli, tra cui l’alcool, la droga, una sessualità vissuta in maniera consumistica. Sono dipendenze, no? E ha concluso quasi con un grido: «Aiutate il nostro mondo giovanile che va sempre più a rotoli». Non so se il mondo giovanile vada sempre più a rotoli, non so. Ma sento che il grido di questa ragazza è sincero e richiede attenzione. Sta a voi rispondere a questa ragazza, colloquiare con questa ragazza. È una di voi e bisogna vedere questo “schiaffino” che ci dà, dove ci porta. Anche nella Chiesa dobbiamo imparare nuove modalità di presenza e di vicinanza. È molto importante. Mi viene in mente quando Mosè vuole dire al Popolo di Dio qual è il nocciolo dell’amore di Dio. E dice: “Pensate: quale popolo ha avuto un Dio così vicino?”. L’amore è vicinanza. E loro, i giovani di oggi chiedono alla Chiesa vicinanza. Voi cristiani, voi che credete nella vicinanza di Cristo, voi cattolici, siate vicini, non lontani. E voi sapete bene che ce ne sono tante, tante modalità di allontanarsi, tante. Educate tutti, con guanti bianchi, ma prendere distanza per non sporcarsi le mani. I giovani, oggi, ci chiedono vicinanza: ai cattolici, ai cristiani, ai credenti e ai non credenti. A tutti. E a questo proposito, un giovane ha raccontato con entusiasmo la sua partecipazione ad alcuni incontri con queste parole. Così dice: «La cosa più importante è stata la presenza di religiosi in mezzo a noi giovani come amici che ci ascoltano, ci conoscono e ci consigliano». Uomini e donne consacrati che sono vicini. Ascoltano, conoscono e a chi chiede consiglio, consigliano. Io conosco alcuni di voi che fanno questo.
Mi viene in mente lo splendido Messaggio ai giovani del Concilio Vaticano II. È anche oggi uno stimolo a lottare contro ogni egoismo e a costruire con coraggio un mondo migliore. È un invito a cercare nuovi cammini e a percorrerli con audacia e fiducia, tenendo fisso lo sguardo su Gesù e aprendosi allo Spirito Santo, per ringiovanire il volto stesso della Chiesa. Perché è in Gesù e nello Spirito che la Chiesa trova la forza di rinnovarsi sempre, compiendo una revisione di vita sul suo modo di essere, chiedendo perdono per le sue fragilità e inadeguatezze, non risparmiando le energie per mettersi al servizio di tutti, col solo intento di essere fedele alla missione che il Signore le ha affidato: vivere e annunciare il Vangelo.
4. Cari giovani, il cuore della Chiesa è giovane proprio perché il Vangelo è come una linfa vitale che la rigenera continuamente. Sta a noi essere docili e cooperare a questa fecondità. E tutti voi potete collaborare a questa fecondità: che siate cristiani cattolici, o di altre religioni, o non credenti. Vi chiediamo di collaborare alla fecondità nostra, a dare vita. Lo facciamo anche in questo cammino sinodale, pensando alla realtà dei giovani di tutto il mondo. Abbiamo bisogno di riappropriarci dell’entusiasmo della fede e del gusto della ricerca. Abbiamo bisogno di ritrovare nel Signore la forza di risollevarci dai fallimenti, di andare avanti, di rafforzare la fiducia nel futuro. E abbiamo bisogno di osare sentieri nuovi. Non spaventatevi: osare sentieri nuovi, anche se ciò comporta dei rischi. Un uomo, una donna che non rischia, non matura. Un’istituzione che fa scelte per non rischiare rimane bambina, non cresce. Rischiate, accompagnati dalla prudenza, dal consiglio, ma andate avanti. Senza rischiare, sapete cosa succede a un giovane? Invecchia! Va in pensione a 20 anni! Un giovane invecchia e anche la Chiesa invecchia. Lo dico con dolore. Quante volte io trovo comunità cristiane, anche di giovani, ma vecchie. Sono invecchiate perché avevano paura. Paura di che? Di uscire, di uscire verso le periferie esistenziali della vita, di andare là dove si gioca il futuro. Una cosa è la prudenza, che è una virtù, ma un’altra è la paura. Abbiamo bisogno di voi giovani, pietre vive di una Chiesa dal volto giovane, ma non truccato, come ho detto: non ringiovanito artificialmente, ma ravvivato da dentro. E voi ci provocate a uscire dalla logica del “ma si è sempre fatto così”. E quella logica, per favore, è un veleno. È un veleno dolce, perché ti tranquillizza l’anima e ti lascia come anestetizzato e non ti lascia camminare. Uscire dalla logica del “sempre è stato fatto così”, per restare in modo creativo nel solco dell’autentica Tradizione cristiana, ma creativo. Io, ai cristiani, raccomando di leggere il Libro degli Atti degli Apostoli: la creatività di quegli uomini. Quegli uomini sapevano andare avanti con una creatività che se noi facciamo la traduzione a quello che significa oggi, ci spaventa! Voi create una cultura nuova, ma state attenti: questa cultura non può essere “sradicata”. Un passo avanti, ma guarda le radici! Non tornare alle radici, perché finirai sotterrato: fai un passo avanti, ma sempre con le radici. E le radici – questo, perdonatemi, lo porto nel cuore – sono i vecchi, sono i bravi vecchi. Le radici sono i nonni. Le radici sono quelli che hanno vissuto la vita e che questa cultura dello scarto li scarta, non servono, li manda fuori. I vecchi hanno questo carisma di portare le radici. Parlate con i vecchi. “Ma cosa dirò?”. Prova! Ricordo a Buenos Aires, una volta, parlando con i giovani, ho detto: “Perché non andate in una casa di riposo a suonare la chitarra agli anziani che sono lì?” – “Ma, Padre…” – “Andate, un’oretta soltanto”. [Rimasero] più di due ore! Non volevano uscire, perché i vecchi che erano così [un po’ addormentati], hanno sentito la chitarra e si sono svegliati, svegliati, svegliati e hanno incominciato [a parlare], e i giovani hanno sentito cose che li toccavano dentro. Hanno preso questa saggezza e sono andati avanti. Questo il Profeta Gioele lo dice tanto bene, tanto bene. Al capitolo terzo. Per me questa è la profezia di oggi: “I vecchi sogneranno, e i giovani profetizzeranno”. Noi abbiamo bisogno di giovani profeti, ma state attenti: mai sarete profeti se non prendete i sogni dei vecchi. Di più: se non andate a far sognare un vecchio che sta lì annoiato, perché nessuno lo ascolta. Fate sognare i vecchi e questi sogni vi aiuteranno ad andare avanti. Gioele 3,1. Leggi questo, ti farà bene. Lasciatevi interpellare da loro.
Per sintonizzarci sulla lunghezza d’onda delle giovani generazioni è di grande aiuto un dialogo serrato. Vi invito allora, in questa settimana, a esprimervi con franchezza e in tutta libertà, l’ho detto e lo ripeto. Con “faccia tosta”. Siete i protagonisti ed è importante che parliate apertamente. “Ma ho vergogna, mi sentirà il cardinale…”. Che senta, è abituato. Vi assicuro che il vostro contributo sarà preso sul serio. Già da ora vi dico grazie; e vi chiedo, per favore, di non dimenticarvi di pregare per me. E quelli che non possono pregare, perché non sanno pregare, almeno mi pensino bene. Grazie.