Dopo diversi anni, un governo viene eletto e scelto dal popolo. Se ci pensiamo, la situazione italiana è paradossale perché per quasi un decennio “non si è più riusciti” a instaurare un Governo attraverso le elezioni e, per una Nazione come l’Italia, cioè una repubblica democratica, si è andati “contro” la propria Costituzione. Nelle passate elezioni del 25 settembre 2022, quelle con la più bassa percentuale di affluenza della storia italiana, Giorgia Meloni ha confermato di gran lunga i pronostici vincendo insieme al centrodestra sia alla Camera che al Senato. Complice di ciò è sicuramente una campagna elettorale di basso livello da parte dei rivali, a partire dal PD. La campagna elettorale della sinistra, a detta anche di moltissimi giornalisti politici, è stata incentrata prevalentemente sulla critica e sull’opposizione delle idee della destra senza però portare avanti spunti concreti per migliorare il Paese. Oltre a ciò, il PD ha dovuto affrontare diverse scissioni interne che si sono rivelate essere state più significative del previsto come quella di Calenda che, unendosi a Renzi, ha posto una base solida per il futuro creando il cosiddetto Terzo Polo.
Tutto ciò ha scoraggiato molti giovani studenti fuorisede, per lo più votanti di sinistra nel campione preso in analisi, che hanno preferito restare a casa anziché andare a votare. Se Letta ha avuto una debacle e si è dimesso, Salvini non può ritenersi del tutto soddisfatto di queste elezioni. La Lega è uscita decimata seppur vincente; i suoi elettori sono rimasti per lo più soltanto al Nord e neanche più in maniera rilevante. Il leader del Carroccio ha pagato (e non poco) la scelta di andare al Governo senza l’appoggio della coalizione. Il risultato è che ora rischia di essere la terza forza della destra alle spalle di Fratelli d’Italia e di Forza Italia che ha incredibilmente raggiunto l’8% grazie anche a un Berlusconi capace di captare e scegliere sempre le strategie migliori. Un risultato impensabile se si pensa che nel 2018 era il secondo partito d’Italia dopo il Movimento 5 Stelle. Quest’ultimo, senza più Di Maio (il suo partito è rimasto fuori dal Parlamento) ha ricevuto un altro, ennesimo, duro colpo post politiche 2018. In questa campagna elettorale, Conte ha attuato una politica molto rischiosa e sbagliata, ma che si è rivelata essere letalmente vincente, soprattutto al Centro-Sud. L’ex premier, incentrando i propri discorsi sul fatto che volesse mantenere il reddito di cittadinanza e ricordando agli italiani che è grazie a lui se attualmente possono beneficiarlo, è riuscito a superare le aspettative di tutti i sondaggi superando il 15%. Nonostante il loro leader sia rimasto molto soddisfatto (un ottimo risultato, gli exit poll lo davano intorno al 11%), la verità è che continua a perdere voti di elezione in elezione e attualmente può fare ben poco per mantenere le promesse elettorali.
Infine, arriviamo alla vera vincitrice di queste elezioni: Giorgia Meloni, la prima donna a capitanare il primo partito d’Italia e forse anche la prima Presidente del Consiglio donna! Un successo per lei, ma anche e soprattutto per tutte le donne che in Italia e nel mondo vengono discriminate in molti settori lavorativi e non solo. Sicuramente la leader di FdI ha avuto dalla sua il fatto di essere stata all’opposizione (ricordiamo che è più facile evidenziare i problemi quando non si governa), ma anche essere una brava nonché efficace comunicatrice sotto tutti i punti di vista. Il suo partito ha visto aumentare i voti a dismisura nel giro di qualche anno, ma mai nessuno avrebbe pensato che raggiungesse il 25% dei voti degli elettori. Di certo, c’è da dire che ha vinto in un periodo storico nel quale i governi continuavano a cadere e i rivali non hanno mai portato dei veri e propri programmi concreti. In più, numerose scissioni interne e litigi estivi hanno fatto sì che molti elettori di sinistra perdessero la fiducia nei loro vecchi partiti andando a fare il classico voto di protesta. Alla luce di ciò, mi auguro un Governo di Ministri che lavorino per il bene del nostro Paese e non per i propri interessi personali; mi auguro persone competenti e all’altezza del ruolo che ricoprono e non burattini messi lì per conoscenze. Mi auguro quindi un Governo che possa lavorare fino alla fine del suo mandato perché qualora dovesse nuovamente cadere significa che avremo perso tutti; mi auguro infine che il nuovo Governo possa far affluire il numero di persone ai seggi, magari attraverso una legge che conceda ai fuorisede il voto nella città di domicilio e non di residenza.
Marco C. – Milano
Author: Giovani Barnabiti
Cómo joven
Hola, mi nombre es Rodrigo Pacheco, tengo 19 años y resido en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Pertenezco a la pastoral de monaguillos desde hace ya más de 8 años, sirvo con gran amor y felicidad a Dios.
Dicho lo anterior, espero que lo que se presenta a continuación les sea de inspiración, motivación y de agrado, ya que a lo largo de este artículo les contaré sobre mi experiencia respecto a mi acompañamiento espiritual con los sacerdotes barnabitas y así mismo dar a conocer un poco de mi formación de vida y de quien soy. Brevemente les puedo mencionar que me considero una persona alegre, me gusta estudiar, y me gusta ayudar a los demás. Nací en un hogar formado en valores y principios que me han servido a lo largo de mi vida y que me van a ayudar cada día ha crecer como persona, ya que considero que más allá de los conocimientos esta la formación ética, moral y espiritual.
Cómo joven, es realmente bueno tomarse un tiempo para dejar a un lado el estrés al que muchas veces estamos sometidos por el trabajo, por la universidad, o por diversos asuntos en los que siempre estamos presentes, los jóvenes hoy en día tenemos que estar atentos para distinguir la voz de Dios, en medio del ruido que muchas veces, no nos permite reflexionar.
Es grato hacerlo en sinfonía con otros jóvenes del mundo y es que en lo largo de los años en los que he estado presente en mi parroquia, me he tomado el tiempo para reflexionar y darme cuenta del impacto que ha tenido para mi ser parte de una comunidad donde los sacerdotes barnanitas, varios de ellos jóvenes, tienen ese gran amor por su servicio: Lo cual me motiva a seguir los pasos que estos sacerdotes nos enseñan.
El convivir con gran parte de los sacerdotes barnabitas, en este tiempo, me ha servido para conocer, vivir y aprender a ser un instrumento de Dios, tal como lo fue San Antonio María Zaccaria, y aquí doy un punto realmente importante para la formación de mi vida, ya que San Antonio María Zaccaria era joven, pero el ser joven jamás fue un impedimento para amar y hacer todo para servir a Dios y a sus hermanos.
Como joven he aprendido a forjar ese amor por el servicio a Dios, y a mi prójimo; considero que es algo realmente hermoso servir, para mí, convivir con mis hermanos es una experiencia única, ver la felicidad de los niños, adolescentes y jóvenes sin duda alguna no tiene un valor comerciable. Los Padres Barnabitas han sido realmente claros, ya que durante todo este tiempo nos han enseñado a poner en práctica el servicio con amor a Dios y a nuestro prójimo, Es una gran bendición tener sacerdotes con ganas de trabajar, mejorar y formar una comunidad mejor, el estar presente en todos los grandes proyectos en los que se ha trabajado, me han servido para mejorar mi vida, ya que es realmente necesario tomarse el tiempo para ser mejor persona.
Tengo que ser sincero, y es que durante el tiempo que estuve redactando este artículo, realmente me di cuenta de todo lo que he logrado gracias a la espiritualidad y la acción de los barnabitas, y es que cada vez soy más feliz en compañía de Dios, comparto mi tiempo con personas increíbles, siento una inmensa paz, y sin duda alguna siento esa presencia tan cercana y hermosa con Dios.
Agradezco mucho la oportunidad de expresarme en este blog, estoy agradecido con los autores por darme esta oportunidad.
San Antonio María Zaccaria, ruega por nosotros.
Rodrigo
Salve!, mi chiamo Rodrigo Pacheco, ho 19 anni e vivo nella città di Merida, Yucatán, Messico. Appartengo al ministero dei chierichetti da più di 8 anni, servo Dio con grande amore e felicità.
Detto questo, spero che quanto presento di seguito serva di ispirazione, motivazione e piacere per altri giovani, poiché in questo articolo vi racconterò la mia esperienza in merito al mio accompagnamento spirituale con i sacerdoti barnabiti e farò conoscere anche un po’ della mia formazione di vita e di chi sono io.
Posso dire brevemente che mi considero una persona allegra, mi piace studiare e mi piace aiutare gli altri. Sono nato in una casa formata da valori e principi che mi hanno servito per tutta la vita fino ad ora e che, con certezza, mi aiuteranno a crescere ogni giorno come persona, poiché credo che la formazione etica, morale e spirituale sia al di là della conoscenza.
Da giovane è davvero bello prendersi del tempo per mettere da parte lo stress a cui spesso siamo sottoposti per motivi lavorativi, universitari o altri in cui siamo sempre immersi, i giovani di oggi dobbiamo essere attenti a distinguere la voce di Dio, in mezzo al frastuono che tante volte, non permette di riflettere.
È un piacere farlo in sintonia con altri giovani di tutto il mondo, perché negli anni in cui sono stato presente nella mia parrocchia di S. Giuseppe Operaio, mi sono preso il tempo per riflettere e realizzare l’impatto che significal’essere parte di una comunità dove i sacerdoti barnabiti, molti dei quali giovani, e vedere che hanno quel grande amore per il loro servizio: che mi spinge a seguire i passi che questi sacerdoti ci insegnano.
La convivenza con gran parte dei sacerdoti barnabiti, in questo momento, mi ha aiutato a conoscere, vivere e imparare ad essere strumento di Dio, proprio come lo fu sant’Antonio Maria Zaccaria, e qui ho un punto davvero importante per la formazione della mia vita, l´ha fatto sant’Antonio Maria Zaccaria fin da giovane, ciò vuol dire che l’essere giovane non è mai stato un impedimento per amare e fare di tutto per servire Iddio ei suoi fratelli.
Da giovane ho imparato a forgiare quest’amore servendo Dio e il mio prossimo; Ritengo che sia qualcosa di veramente bello – il servire –, per me vivere con i miei fratelli è un’esperienza unica, vedere la felicità di bambini, adolescenti e giovani, senza dubbio, non ha un valore commerciabile. I Padri Barnabiti sono stati molto chiari, poiché in tutto questo tempo ci hanno insegnato a mettere in pratica il servizio con amore a Dio e al prossimo, è una grande benedizione avere sacerdoti disposti a lavorare, migliorare e formare una comunità migliore, l’essere presente in tutti i grandi e piccoli progetti su cui si è lavorato, mi ha aiutato a migliorare la mia vita, poiché è davvero necessario prendersi il tempo per essere una persona migliore.
Devo essere onesto, ed è che durante il tempo in cui stavo scrivendo questo articolo, ho davvero realizzato tutto ciò che ho ottenuto grazie alla spiritualità e all’azione dei Barnabiti, ed è che sono più felice in compagnia di Dio, condivido il mio tempo con persone incredibili, sento una pace immensa e senza dubbio sento quella presenza così vicina e bella con Dio.
Apprezzo molto l’opportunità di esprimermi su questo blog, sono grato agli autori per avermi dato questa opportunità.
Rodrigo
Sant’Antonio Maria Zaccaria, prega per noi.
Svegli alle 8
Perché mai l’8 / 08 alle 8.00 del mattino essere svegli (per forza o per davvero non saprei) a Mil8 (Milot la missione dei Barnabiti in Albania)?
Amici e colleghi e … a quest’ora ancora dormono o sono in questo o quel luogo ameno dove il caldo c’è ma non insidia come qui, dove cornetti/brioches e cappuccini imperversano e, nonostante ciò, alcuni giovani italiani e albanesi sono svegli per… (udite, udite anzi leggete, leggete) per giocare.
Sì, per giocare. Termine e concetto forse desueto, ma questi giovani sono qui per giocare, perché il gioco, libero, senza smartphone (o quasi) con qualche regola da raggirare (altrimenti che gioco sarebbe?) è sempre importante per crescere e far crescere.
In questa società mondiale dove bambini e adolescenti sono sempre più fagocitati dal gioco virtuale e dalle relazioni virtuali post(?)Covid; scommettere su un giocare reale, sbucciarsi ancora le ginocchia, tradurre le regole dall’italiano all’albanese; affrontare ragazzini esuberanti (per usare un eufemismo) che vogliono boicottare i giochi solo per dirci: “Ci siamo anche noi!”; scoprire quali sono i giochi migliori da proporre e realizzare secondo le loro esigenze e non le nostre idee; in questa società mondiale fagocitata dal virtuale, il gioco è la carta più bella da giocare per costruire il futuro. (Permettetemi una digressione geopolitica: per costruire la pace, nonostante questa terza guerra mondiale a pezzi!)
Venire a Mil8 richiede di “consumare” i giorni delle proprie ferie, di far finta di non essere stanchi del lavoro a Roma o Milano o Cremona o Firenze o…; diciamolo con franchezza, richiede un po’ tanta incoscienza! Quella incoscienza che spesso i barnabiti predicano in nome di sant’Antonio Maria Zaccaria! Una incoscienza zaccariana che questi nostri giovani realizzano anche se non conoscono a memoria gli Scritti di SAMZ.
Svegli alle 8 dell’8/08 a Mil8 perché il buon giorno si vede dal mattino.
Svegli alle 8 per svegliare noi adulti, per dirci che nonostante tutto qui e in altre parti dell’Albania o del mondo ci sono ancora persone che credono nella possibilità di fare il bene perché prima di tutto raccolgono bene per se stessi. Perché tutti abbiamo bisogno di bene.
In questi due anni questi giovani hanno lavorato molto da remoto per tenere viva la propria passione per Mil8, per la nostra missione, per la propria amicizia nata con i primi KampiVeror 15 anni fa; per capitalizzare le esperienze, le sfide, gli errori, per ricordare che il bene va sempre coltivato; per essere credibili verso tutti coloro che hanno offerto soldi e strutture per far funzionare la “macchina”, non potendo essere qui concretamente (grazie davvero a tutti gli sponsor di questa estate).
Questi due anni da remoto non potevano restare “remoti”, avevano bisogno di concretezza, del campo da gioco di Mil8, nonostante tante difficoltà. Per questo ai nostri giovani italiani e di Milot e FusheMilot e Gallate non costa fatica essere svegli alle 8 anche questo 8/08 a Mil8!
Sicuramente o quasi questo sarà l’utlimo KampiVeror a Milot perché la missione tra qualche mese chiuderà: ognuno elabori le proprie riflessioni e conseguenze. Abbiate almeno il coraggio e la pietas di ringraziare questi giovani svegli alle 8 dell’8/08 a Mil8!
Sicuramente questi giovani già svegli alle 8 di questo 8/08 a Mil8 sapranno elaborare altre sorprese e sollecitare noi adulti e barnabiti a continuare a giocare nella vigna del Signore. Prendiamoci le nostre responsabilità!
Grazie giovani zaccariani già svegli alle 8 del 8/08 a Mil8!
Faleminderit, Zoti ju bekoftë
Giannicola Maria Simone prete
Insegnaci a pregare
No, non è una semplice battuta il titolo.
Oggi molti uomini e donne e giovani non pregano più e quando ne avrebbero bisogno non ne sono consapevoli e non sanno come fare.
Allora Salvini con tutte le sue madonne e rosari così come Achille Lauro con il suo autobattesimo sanremese (vedi mio ultimo articolo) ci ricordano che l’uomo e la donna hanno anche una dimensione spirituale da cui non possono fuggire, con la quale devono confrontarsi.
Ho commentato su twitter l’uscita madonnara del sig. Salvini, chiedendo ai cristiani almeno di rifletterci sopra molto attentamente. Ho ricevuto circa 250 riscontri tra like e risposte. Molto pochi arrabbiati, molti di condivisione e approfondimento sia di credenti sia di non credenti, compresi TheManeskin!. Non so se i conservatori non usino twitter o si siano defilati perché questa volta si è superato il limite.
Però un fatto è certo il sig. Salvini sa dove parare, ma la gente non è del tutto stupida e i cristiani non del tutto ingenui.
Sa dove parare perché la gente, ognuno di noi, non può fare a meno della dimensione spirituale dell’esistenza (chiamiamola anche religiosa) e quindi perché non cavalcarla? Il problema è che molti dei credenti (mi fermo in casa mia) forse non sanno più come rispondere all’esigenza spirituale di ogni loro simile, esigenza sopita o no.
Pregare è un’arte che riguarda tutti, scriveva Massimo Recalcati qualche anno fa, anche chi non è credente.
Ma noi non chiediamo più a nessuno di insegnarci a pregare perché non abbiamo più bisogno di pregare e quand’anche ne avessimo bisogno ci rivolgiamo a questa o quella realtà non spirituale o di una dubbia o effimera spiritualità.
Nel vangelo i discepoli chiedono a Gesù di insegnare loro a pregare, ma noi uomini, donne,
giovani di oggi a chi chiediamo di insegnarci a pregare? Ovvero se qualcuno ci chiedesse di insegnare loro a pregare come e cosa gli risponderemmo?
Abbiamo perso l’abitudine di pregare veramente, di conseguenza siamo incapaci di trasmettere il pregare e quindi nessuno più ci chiede di pregare.
La preghiera è quello strumento con cui possiamo entrare nell’intimità della vita, nell’intimità di noi stessi, nell’intimità di Dio. Ci sono molti modi per entrare nelle intimità della vita e di se stessi. Potrebbe bastare così per essere persone equilibrate e serene verso la vita e verso se stessi. In questo modo però la preghiera resta un buon strumento ma chiuso in se stesso, semplice propria azione di buona volontà, incapace di riconoscersi come un dono ricevuto per diventare dono.
Se per ogni uomo buono ciò è rischioso, per un cristiano lo è ancora di più. Il cristiano che è tale perché ha ricevuto “in dono” la fede e il nocciolo della fede, l’Incarnazione di Dio e il dono dello Spirito santo, vivere piegato solo sulle proprie cose buone non è bene. Non pregare, non voler pregare, non sapere pregare conduce anche il cristiano a pensare solo a se stesso, non per cattiveria, ma per maleducazione.
Il fatto stesso che molti di noi adulti non siano stati capaci di trasmettere il bello e il dono della preghiera è un chiaro segno di questa maleducazione. Una maleducazione che ha portato molti nostri giovani anche a pregare, ma spesso a non essere consapevoli di come pregano e di chi pregano. Tra questi adulti maleducanti mi ci metto anche io.
Parlare di questa maleducazione non significa colpevolizzare questo o quello ma cercare di diventare consapevoli di una fatica, di una incapacità che sta creando molti danni. Se la preghiera è il modo proprio di essere cristiani, di essere uomini e donne, di amare, di vivere e morire (come tutta la Bibbia ci insegna) non essere più capaci di insegnare a pregare è un dramma, una colpa profondi.
Insegnare a pregare significa almeno due cose: scoprire ed edificare la propria vita interiore, scoprire ed edificare il proprio essere figli.
In troppi dialoghi con giovani credenti o no, vicini o lontani, troppo scopro l’incapacità di costruire una propria vita interiore e quindi l’incapacità di affrontare in profondità la bellezza del proprio esistere. La mancanza di una vita interiore è l’altra piaga della nostra umanità, connessa al non sapere pregare.
Certo ci sarebbero gli psicologi per aiutare a fare ciò, ma la psicologia, quando è seria, entra nelle dinamiche dell’esistenza per sbrogliarne la matassa però non può rispondere alla domanda di senso e specialmente alla consapevole scoperta dell’essere figli.
Infatti, la preghiera cristiana, conduce a scoprirsi figli non di un Dio sconosciuto ma di un Dio che in Cristo si è rivelato Padre a ognuno di noi e nel dono dello Spirito si fa riconoscere come tale in modo sempre rinnovato, originale e personale.
La preghiera cristiana è sempre rivolta a un Dio che è Padre, Padre e Madre disse papa Luciani, e proprio per questo, nonostante i limiti e gli abusi dell’umanità cristiana, permette al credente di sapere da dove viene, dove è e dove va, permette di trasgredire e proprio per questo di essere libero.
La mia preghiera personale percepisce quanto ho cercato di scrivere; ma non credo di essere molto bravo nell’insegnare a pregare, nel testimoniare una preghiera buona.
Un giorno un alunno mi disse: io non credo, però nel vedere come lei si è inginocchiato e ha fatto un segno della Croce, mi ha fatto percepire che l’uomo non può vivere di sole cose materiali.
Se ciascuno di noi con la propria preghiera riuscisse anche solo a lasciare qualche piccolo segno, a sollecitare qualche domanda nel proprio prossimo non avremmo più bisogno di mercanti della preghiera.
Solo un recupero di una preghiera in armonia con sé, con la vita e con Dio può rispondere a quel bisogno di maturità umana che tutti cercano ma pochi vogliono percorrere, come si dicevano l’un l’altro il credente cardinal Martini e l’ateo filosofo Norberto Bobbio.
Violenza di gruppo.
La violenza è il modo in cui molti uomini e molte meno donne cercano di dire quello che non sanno dire di se stessi o della vita.
La violenza in tutti i suoi livelli, non solo quelli materiali, è l’incapacità di sapere affermare se stessi di fronte agli altri. È l’incapacità di saper gestire la propria libertà perché incapace di incontrare la libertà altrui. È cosi già dai tempi di Caino e Abele.
La violenza contro il più debole, perché donna?, perché diverso da …, perché più fortunato di me o perché incontrare l’altro comunque inconsciamente spaventa? E non importa se più grande o piccolo di me.
Confesso che una sera, camminando in centro a Milano, con alcuni adolescenti l’incrociarsi con altri adolescenti visibilmente di origine non milanese provenienti dalle periferie mi ha fatto pensare, preoccupare un poco e allertare le “antenne”.
Forse solo perché caciarosi, perché in gruppo, perché “stranieri” pur parlanti italiano?
Intanto, senza la pretesa di una analisi professionale, la violenza non riguarda solo ragazzi di prima, seconda, terza generazione: la violenza è un fenomeno che coinvolge molti uomini e meno donne di ogni razza, censo, estrazione sociale e/o interessi. Certo poi è più facile stigmatizzare alcune realtà piuttosto che altre. Secondo alcuni, altri alcuni per forza sono violenti perché di seconda generazione, perché incapaci di accogliere le regole.
Come scriveva Giuliana Tondini, procuratrice tribunale dei minori di Brescia, quello che preoccupa è oggi l’accelerazione con cui oggi si radunano le bande violente, basta un TikTok. «Questa accelerazione non favorisce il pensiero riflessivo, ma privilegia risposte istintuali e spesso violente.» La fatica di riflettere.
Dei ragazzini, non pochi, di cosiddetta seconda generazione hanno fatto violenza su alcune loro coetanee agli inizi di giugno su un treno da Peschiera del Garda verso Milano. Ragazzi che poco prima si erano ritrovati per un raduno “etnico-tribale” come ce ne sono tanti altri in Italia e non solo e non solo di ragazzini.
Ragazzi che probabilmente hanno trovato ispirazione in tanta musica che permettiamo di ascoltare perché tanto è solo musica. (a questo proposito leggi https://www.marcobrusati.com/categorie/musica-video/490-idoli-del-trap-de-cantano-droga-violenza-e-ragazze-prede-sessuali).
Il fatto verrà giudicato e sanzionato dalle autorità competenti; il recupero delle loro vite e la rielaborazione del trauma delle vittime saranno la missione delle famiglie e degli specialisti competenti. Speriamo.
Non era e non è facile affrontare queste realtà che chiamiamo disagio. Sicuramente la politica ostacolando qualsiasi proposta di legge per un riconoscimento di cittadinanza non comprende che ciò significa ignorare che l’immigrazione è sempre una complicazione, da che mondo è mondo, e va affrontata.
«Non credo che tutti i giovani e turbolenti immigrati diventerebbero agnellini, ottenuta la cittadinanza, come la cittadinanza di per sé non aggiusta le teste matte dei giovani turbolenti di nostra produzione. Ma forse avrebbero una ragione in meno per sentirsi sradicati e stranieri nella terra dove sono cresciuti, e dove un aspirante leader li considera indegni di noi.» (M. Feltri, LaStampa, 1 luglio 2022).
Dobbiamo continuare a vigilare e creare spazi di incontro e di riflessione (non solo scuola che a molti adolescenti dà un senso di fastidio) per gli adolescenti; dobbiamo trovare il modo di far percepire che verso gli adolescenti c’è fiducia, non solo sopportazione. I tempi di “ri-costruzione” saranno lunghi ma porteranno frutti se sapremo dare loro tempo di ascolto e proposte di vita, se sapremo far riscoprire il valore dei “sì” e dei “no”! Non è un lavoro semplice, richiede molta rete, specialmente con quanti di cosiddetta seconda generazione – per restare nel campo – hanno raggiunto dei successi. Altrimenti si rischiano sempre livelli distinti e lontani che continueranno a distinguere e allontanare.
Ambasciatore del clima
Il cambiamento climatico. Tutti sappiamo, chi per sentito dire, chi per conoscenze più specifiche, cosa sia il cambiamento climatico. Tale problematica ha infatti assunto molta importanza negli ultimi anni grazie a manifestazioni su scala globale come il “Friday for Future” Tuttavia forse non tutti sono a conoscenza della gravità del fenomeno, dell’impatto che esso ha concretamente sulle nostre vite, e degli enti, associazioni e organismi internazionali che ogni giorno tentano di agire per cercare di arginare tale problematica.
Abbiamo intervistato Andrea Grieco, stratega della sostenibilità, che ci ha spiegato in cosa consiste il suo lavoro, quali sono le problematiche legate al cambiamento climatico e gli obbiettivi principali raggiunti, o ancora da raggiungere, per raggiungere un mondo e un’economia sostenibile.

-Iniziamo con le presentazioni. Chi sei, da dove vieni, come sei arrivato a svolgere questo lavoro?
-Sono Andrea Grieco. Son nato in Basilicata, ho origini Lucane. È una terra molto povera ma ricca di natura, ed è stato proprio a partire da questo contatto diretto con l’ambiente selvaggio della mia terra di origine che ho sviluppato il mio interesse per queste tematiche, insieme a quello per i diritti umani.
Ho deciso infatti di studiare giurisprudenza, specializzandomi in diritto internazionale, e mi sono formato in seguito sul tema della sostenibilità e dell’immigrazione. Facendo poi un master delle Nazioni Unite ho studiato l’agenda 2030 e gli obbiettivi per lo sviluppo sostenibile e il tema del cambiamento climatico.
Dopo aver concluso gli studi, ho creato il mio lavoro: sono uno stratega della sostenibilità, aiuto le aziende o varie realtà ad allinearsi con gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile e ad integrare gli obbiettivi della sostenibilità nel loro business e attività.
-Hai citato l’Agenda 2030 e l’obbiettivo dello sviluppo sostenibile. Puoi spiegarci cosa si intende con questo termine?
-L’Agenda 2030 è un manifesto creato dalle Nazioni Unite nel 2015 per indirizzare il mondo verso uno sviluppo sostenibile economico e umano. È formata da 17 obbiettivi. Con 169 micro obbiettivi al loro interno che coprono tutte le dimensioni dello sviluppo umano. Si basa su cinque concetti chiave: Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta. L’obiettivo è quello di ridurre disuguaglianze, povertà, favorire la prosperità sul lavoro, e creare partenariato per la sostenibilità.
-Quale è in questo momento il tuo obbiettivo principale?
– Credo che il goal 17, quello delle Partnership, sia fondamentale. Se non si mettono insieme conoscenze e competenze differenti non si raggiungerà mai lo sviluppo sostenibile. Un altro goal fondamentale è il numero 10, per ridurre le disuguaglianze e garantire pari diritti per tutti, e il 13 per la lotta al cambiamento climatico attraverso divulgazione e formazione.
–Credi che questa tematica sia effettivamente sentita e percepita come importante all’interno della società?
– Credo ci sia molta consapevolezza. Tuttavia, non dovremmo essere più nella fase della sola consapevolezza, ma dovremmo passare allo step successivo: riuscire a creare politiche per combattere attivamente il cambiamento climatico, ma ancora non ci sono azioni concrete. L’Italia, per esempio, è molto indietro su questa tematica rispetto ad altri paesi e realtà europee.
–Cosa è possibile fare concretamente, sia sul piano delle “macro” azioni, sia nella nostra sfera “micro”, nella vita di tutti i giorni?
-Dal punto di vista politico, si devono creare politiche aperte e inclusive e di collaborazione per combattere il climate change. Credo, inoltre, che ogni singolo individuo possa e debba contribuire e fare la sua parte. Ognuno può informarsi, perché solo conoscendo cosa sono i cambiamenti climatici possiamo provare ad arrestarli. È importante un’informazione che sia consapevole, che si basi su fonti attendibili, non superficiali. Possiamo attuare molte piccole accortezze nella vita quotidiana, come ridurre il consumo di carne, staccare prese di elettrodomestici per ridurre il consumo di energia, smettere di comprare fast fashion usa e getta, e scegliere capi che durino di più a lungo.
-Quale è una conquista che hai fin qui ottenuto e di cui sei particolarmente soddisfatto?
-Sicuramente aver parlato di cambiamento climatico in molte realtà che eran lontane da questo tema. Inoltre, un obbiettivo per me molto importante è poter parlare della realtà e della problematica legata ai migranti climatici e aver presentato in merito una possibile soluzione politica a livello internazionale alle Nazioni Unite. È una tematica poco conosciuta e che credo debba essere approfondita. È un fenomeno molto difficile da inquadrare, sia dal punto di vista giuridico sia causale. Le migrazioni climatiche sono dovute a motivi ambientali o legati al cambiamento climatico. I migranti climatici, tuttavia, non sono tutelati dal diritto internazionale, in quanto la Convenzione di Ginevra del 1951 afferma che hanno diritto all’asilo le persone che migrano per motivi legati a violazioni dei diritti umani o per situazioni di guerra. A oggi, una persona che scappa per motivi climatici non ha garantita protezione e accoglienza in altri paesi. Tuttavia, è un enorme problematica: secondo le stime dell’international displacement monitoring center, tra il 2019 e il 2020 sono migrate 23,9 milioni di persona per motivi legate ai cambiamenti cimatici, e tale numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni. Credo quindi sia fondamentale affrontare questo tema, ampliare la conoscenza di tale fenomeno, che ci riguarda molto più da vicino di quanto pensiamo. Anche l’Italia, infatti, risente risentirà in misura sempre maggiore dei danni provocati dai cambiamenti climatici, e potremmo diventare noi stessi dei migranti climatici.
-Dunque quali azioni concrete potrebbero essere prese riguardo alla tematica dei migranti climatici?
-Sicuramente creare strutture di partenariato e fondi per aiutare i migranti. In questo caso il singolo non può fare altro se non chiedere protezione per queste persone. Sono i politici che dovrebbero agire con leggi e iniziative volte a tutelare questa fascia vulnerabile.
–Credi quindi che ci sia un modo per evitare questo declino a cui sembra di stare inevitabilmente andando incontro?
-Purtroppo siamo molto indietro e non credo ci sia modo di arrestare il cambiamento climatico. L’unica cosa da fare ormai, credo sia adottare strategie di adattamento, per provare a proteggere le persone e il pianeta. Non abbiamo più tempo e i dati lo confermano.
Giulia C. – Firenze
The Barnabites and young people after Covid
To the Barnabite brothers.
The 125th anniversary of the canonization of St. Antonio Maria Zaccaria, thanks to the teaching of some of our illustrious fathers, introduced us to the living heart of our Founder to learn how to become witnesses of Christ here and now, not in the 16th century!
Together with a cultural and spiritual preparation we have tried to reach you in order to reflect on young people, because they are our future. Unfortunately, very few of you have given answers: too busy or too disinterested in thinking about your own pastoral service to young people? Maybe afraid of thinking, praying and proposing at the same time?
The service for young people should still be the way to characterize our being Barnabite priests, and yet there is a lack of shared reflection that must make us think.
The Covid pandemic has touched all of our realities as it had never happened in the past: we must look together for answers and new paths as never before, because we cannot simply start from where we stopped.
Certainly it is not possible to find new answers and paths in just two years, but they can be searched, investigated, proposed. Also because, as you highlighted in your replies, Covid has actually caused damages: fear, isolation, little trust in adults, greater use of smartphones, relationship fatigue. The almost complete recovery of daily activities has left many … at home and others – especially teenagers – with a bitter taste in their mouth. In Europe, in addition, the situation of the war in Ukraine is continuing this drama.
With regard to the denunciation of the Archbishop of Milan, Mario Del Pini: “Young people no longer perceive the Church as an interlocutor for their questions, the Church experiences this as a defeat: we have lost a bet.”; but also to the hope of the Archbishop of Hong Kong, Stephen Chow: “There is a need for a vision. And there is a need to understand the present and the context. Don’t look at the walls, look at the future. »: We cannot act alone.
Starting from these assumptions: defeat and vision, we want to try to let ourselves be moved by the Zaccharian vigor of the beginning which, despite the short life of the Founder, was not in vain: moving with continuity on the path that the vocation of each of us is called to live. The confreres who responded highlighted the need of young people to be listened to, to be taken with attention and seriousness; I wonder: how do we listen to young people? From the Philippines to Brazil, everyone is asking to enhance a renewed missionary style.
This new missionary style is recognized as typical of our charism, but it must be thought and rethought and prayed together, with a synodal spirit and method that becomes a life testimony, especially because our forces have decreased.
Perhaps we should think more about the two words: defeat and vision, and in this we should be helped by the defeats and visions of our Antonio Maria and his first collaborators. This is also the line indicated by the recent Synod of Youth, which is not archived.
Thanks to Fathers Giovanni Giovenzana from Eupilio, Giorgio Viganò from Cremona, Giuseppe di Nardo from Bari, Michael Sandalo from Silangan, Junior Cavalcante from Belem, Ferdinand Mushagalusa from Moucron and Carlo Giove from Naples, Pascal Balumebaciza Pilipili from Buenos Aires.
p. Fabien M. Muvuny,
p. Giannicola M. Simone, Youth Ministry Office of the Barnabite Fathers. May 27, 2022
I Barnabiti e i giovani dopo la Covid
Ai confratelli Barnabiti,
Il 125° anniversario della canonizzazione di S. Antonio Maria Zaccaria, grazie agli insegnamenti di alcuni nostri padri illustri ci ha introdotti nel cuore vivo del nostro Fondatore per capire come diventare testimoni del Cristo qui e ora, non nel secolo XVI!
Unitamente alla preparazione culturale e spirituale abbiamo cercato di raggiungervi per riflettere sui giovani, perché i giovani sono il nostro futuro. Purtroppo molto pochi di voi hanno dato delle risposte: troppo impegnati o troppo disinteressati a pensare il proprio servizio pastorale ai giovani? Forse paura di pensare, pregare e proporre insieme?
Il servizio ai giovani dovrebbe essere ancora il modo di caratterizzare il nostro essere pastori barnabiti eppure c’è un deficit di riflessione condivisa che deve farci pensare.
Mai come nel passato la pandemia di Covid ha toccato tutte, tutte le nostre realtà: mai come nel presente dobbiamo cercare insieme delle risposte, delle strade nuove, perché non si può semplicemente partire da dove ci siamo fermati.
Certo non si può in soli pochi due anni trovare risposte e strade nuove, però si possono cercare, sondare, proporre. Anche perché come avete rilevato nelle risposte, i danni della Covid ci sono stati: paura, restare con se stessi, poca fiducia negli adulti, maggiore uso degli smartphone, fatica di relazione. Il recupero quasi totale delle attività quotidiane ha lasciato molti … a casa e gli altri – specialmente adolescenti – con dell’amaro in bocca. In Europa poi la situazione della guerra in Ucraina sta continuando questo dramma.
Di fronte alla denuncia dell’Arcivescovo di Milano, Mario Del Pini: «I giovani non avvertono più la Chiesa come una interlocutrice per le loro domande, la Chiesa vive ciò come una sconfitta: abbiamo perso una scommessa.»; ma anche alla speranza dell’Arcivescovo di Hong Kong, Stephen Chow: «C’è bisogno di visione. E c’è bisogno di capire il presente e il contesto. Non guardare i muri, guardare il futuro.»: non possiamo agire da soli.
Muovendo da questi presupposti: sconfitta e visione vogliamo cercare di lasciarci muovere dal vigore zaccariano degli inizi che, nonostante la vita breve del Fondatore, non è stato invano: muovendoci con piede continuato nel cammino che la vocazione di ognuno di noi è chiamato a vivere. I confratelli che hanno risposto sottolineano il bisogno dei giovani di essere ascoltati, di essere presi con attenzione e serietà; mi viene da chiedervi: come ascoltiamo i giovani? Dalle Filippine al Brasile tutti chiedono di incrementare un rinnovato stile missionario.
Questo nuovo stile missionario è riconosciuto come proprio del nostro carisma, ma va pensato e ripensato e pregato insieme, con uno spirito e metodo sinodale che si fa testimonianza di vita specialmente perché le nostre forze sono diminuite.
Forse dovremmo ragionare di più sulle due parole: sconfitta e visione e in questo farci aiutare dalle sconfitte e dalle visioni del nostro Antonio Maria e dei suoi primi collaboratori e collaboratrici. È questa anche la linea che ha indicato il recente Sinodo dei Giovani che non è archiviato.
Grazie ai padri Giovanni Giovenzana di Eupilio, Giorgio Viganò di Cremona, Giuseppe di Nardo di Bari, Michael Sandalo di Silangan, Junior Cavalcante di Belem, Ferdinand Mushagalusa di Moucron e Carlo Giove di Napoli, Pascal Balumebaciza Pilipili di Buenos Aires.
p. Fabien M. Muvuny, p. Giannicola M. Simone, Ufficio di Pastorale Giovanile dei PP. Barnabiti. 27 maggio 2022
4 chiacchiere con Francesco Costa sull’informazione per il 9 compleanno del nostro blog
Chiacchierata con Francesco Costa, vice direttore de ilPost.it per il 9 compleanno del nostro Blog
Celebrare un compleanno non significa soltanto contare gli anni; vuol dire anche dare senso e significato a quegli anni. Quelli passati e quelli che verranno. A ogni compleanno della nostra esistenza si fanno bilanci e propositi, si tirano somme e si progetta il futuro. E come per ogni compleanno che si rispetti, festeggiamo il nono anno di vita del nostro blog www.GiovaniBarnabiti.it, e della sua costola cartacea IlGiovaniBarnabiti, regalandoci una preziosa intervista a Francesco Costa, vicedirettore del Post.it, programmando impegni e coltivando sogni e speranze di dare voce al futuro.
Qualcuno potrebbe contestarci che sia un regalo troppo “laico” per la nostra testata, ma la tradizione barnabitica è sempre stata attenta all’incontro con il mondo intorno a sé per annunciare, per far conoscere, per imparare.
D’altra parte nella bella chiacchierata con Francesco Costa (Catania, 1984) emerge subito il dato per cui scrivere significa, prima di tutto, andare “oltre il proprio ombelico” per parlare di e con altri. È il primo consiglio che ci ha fornito Costa, in una breve riflessione sulla comunicazione, sul giornalismo odierno, con i suoi punti di forza e di debolezza, sulla scrittura come strumento per comprendere la complessità del reale.
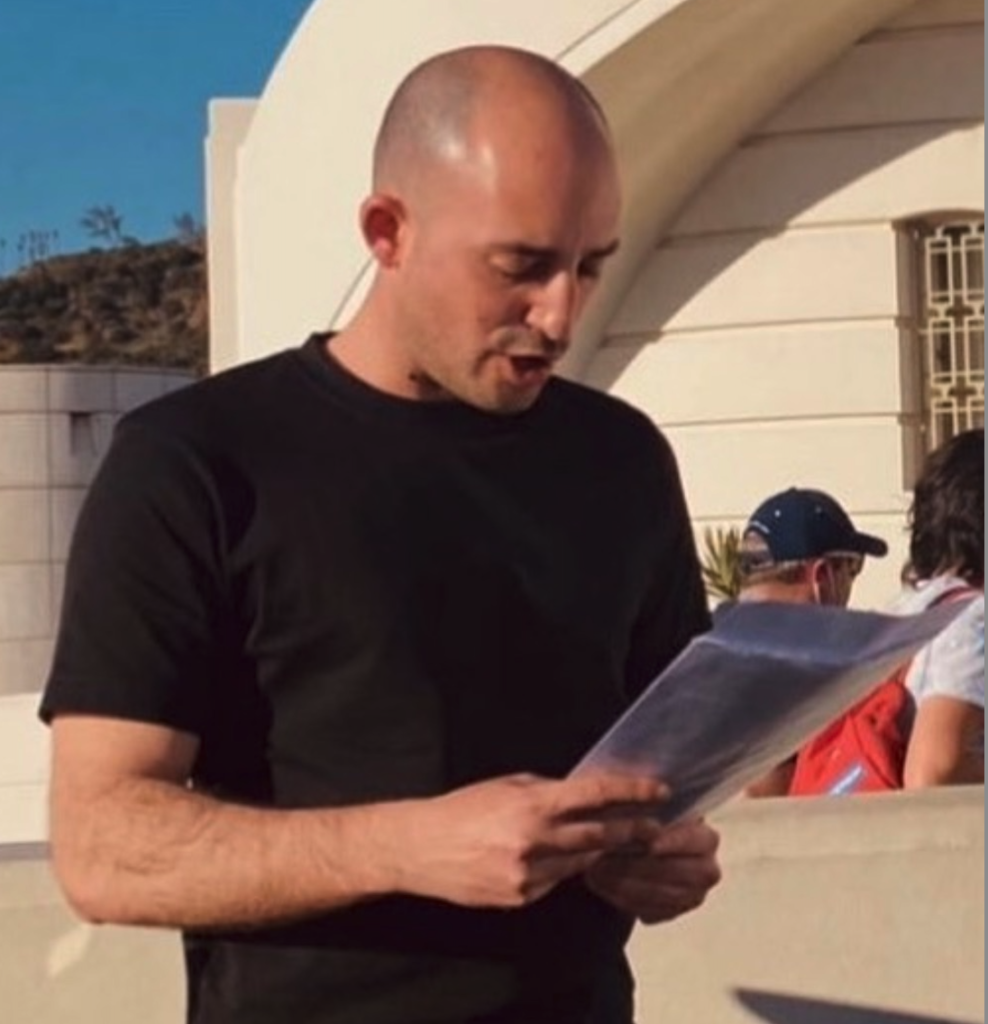
«Scrivere, mettere inchiostro su carta – ha detto Costa – ci costringe a pensare a ciò che scriviamo, quindi a ragionarci, a confrontarci con le persone che abbiamo intorno, ci spinge a essere curiosi. Per questo può essere uno strumento molto utile per comprendere la realtà. Dovremmo provare a utilizzare la scrittura non soltanto per raccontare se stessi, ma anche per raccontare il prossimo. Attraverso la scrittura dovremmo provare ad esplorare mondi sconosciuti, ad andare oltre noi stessi, al di là di un esercizio da diario che definirei ombelicale».
In un mondo così complesso, bombardato di innumerevoli informazioni, dove anche le notizie si prestano a diventare terreno di scontro e non occasione di crescita, invitare i giovani a scrivere significa dare fiducia alle loro capacità, alla loro abilità di analisi e di prospettiva non inferiore a quella degli adulti, sottolinea Costa. E noi concordiamo: tenere aperto un blog, anche senza pretese immense deve essere l’occasione di educare a informazioni sempre fondate e ragionate. Educare all’informazione; rendere consapevole il lettore: è questa la vera sfida nell’attuale ecosistema informazione. “La rapidità dell’informazione – spiega Costa – che comunque considero un vasto arricchimento, ci ha disabituati al fatto che queste stesse informazioni andrebbero maneggiate con cautela, verificate. Non sempre il primo racconto, la prima testimonianza è quella vera. Inevitabilmente la velocità è nemica della precisione. Sono tutti elementi di cui il lettore deve essere consapevole”. Non per smettere di leggerle ma per essere per orientarsi e meglio comprendere.
«Non credo – continua – che i giovani siano più vittime di altri di questa complessità odierna delle informazioni. Anzi mi sembra che nelle abitudini di lettura ci sia nei giovani maggiore curiosità, maggiore voglia di comprendere come funziona la realtà, dunque un vantaggio in più rispetto a chi è più adulto».
Ma quanto la frammentarietà, aggiunta alla velocità dell’attuale ecosistema informazione, ne danneggia la qualità? «C’è sicuramente una crisi industriale – spiega – Meno soldi, meno pubblicità, dunque meno persone, meno tempo da dedicare alle cose, quindi meno qualità. Ma c’è anche – quasi come una conseguenza – una crisi professionale che si spiega con una diversa cultura del lavoro e con un approccio superficiale alle cose. La velocità probabilmente ha aggravato la situazione”.
In considerazione di questo scenario non possiamo che essere ancor più attenti ai giovani, specie a quelli che ancora vogliono – e ci chiedono – di pensare. Ma domandiamo: in che modo?
«Sicuramente coltivando la curiosità rispetto al mondo che ci circonda. Se pensiamo che informarsi sia importante, dobbiamo fare un piccolo investimento anche in termini di tempo: non possiamo pensare che la nostra informazione sia frutto soltanto di una selezione casuale di notizie. Che sia leggere un giornale, ascoltare un podcast, leggere libri: ognuno trovi lo strumento più adatto ai suoi interessi ma decida ogni giorno di fare qualcosa per la propria informazione. Perché sia utile».
Questa riflessione sul cercare il “tempo per” ci porta all’ultima domanda, forse la più impegnativa, come ci dirà il nostro interlocutore.
Il 27 maggio ricordiamo la canonizzazione del nostro Fondatore Antonio Maria Zaccaria (1502-1539), per noi una sorta di padre. Aldilà della dimensione specificamente religiosa che questa data ha per noi Barnabiti, e per le varie realtà legate alla nostra comunità, chiediamo a Francesco Costa, di quale paternità avrebbero bisogno – a suo parere – i giovani di oggi?
«È una domanda molto bella e impegnativa. Di una paternità che possa andare oltre l’idea biologica di paternità. Credo che i giovani abbiano bisogno di una paternità fondata sull’esempio. Mi sembra, da sempre, la cosa migliore che possano fare le persone adulte, quelle che hanno un ruolo di guida di una comunità, qualunque essa sia. Nei rapporti tra adulti e giovani l’esempio mi sembra la chiave fondamentale. Si può insegnare e parlare tantissimo, ma se manca il cuore non si trasmette ciò che si comunica».
Sarebbe stato interessante scambiarci altre idee, ma il tempo del lavoro e la saggezza di non volere il troppo ci hanno indotti ai saluti e a un ringraziamento reciproco per l’arricchente occasione di approfondimento.
Le riflessioni di Costa sulla necessità di trovare il tempo opportuno per l’approfondimento e la riflessione, l’idea di una paternità fondata sull’esempio, ben si legano a quello “stile zaccariano” annunciato dal nostro Fondatore. Antonio Maria chiede infatti con forza di andare sempre alla profondità delle cose, di non restare nel campo della superficialità, della tiepidezza. Noi, con umiltà, impegno e costanza, ci proviamo.
Grazie Francesco Costa e Buon compleanno GiovaniBarnbiti.it
pJgiannic e Raffaella DM
In carcere ho conosciuto Gesù
“Poichè ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi” Mt 25, 31-46
Il carcere può essere, per molti, un luogo oscuro, triste, dimenticato e crudele. Si pensa che lì si trova il peggio della società, coloro che, in molti casi, non meriterebbero neanche di essere chiamati “persone”.
Oggi voglio condividere un po’ della mia esperienza come membro del gruppo Kolbe, che è parte della pastorale penitenziaria della città di Mérida, nello stato dello Yucatán, Messico.
Visitai il carcere per la prima volta 6 anni fa, e devo ammettere che me lo immaginavo giusto come si vede nelle serie TV o nei film. Avevo molti dubbi e anche un poco di paura. Credo che la mia preoccupazione più grande era sapere che avrei dovuto conversare con le persone recluse lì dentro. Posso dire con sicurezza che quella prima visita mi cambiò la vita: ho capito, infatti, che l’amore di Dio trascende luoghi e circostanze. Incontrai un Dio che vive attraverso tutti i fratelli che si trovano nel carcere.
Ho capito che anche nei luoghi più oscuri, Dio è capace di illuminare e spargere il suo amore in ogni momento. Ho conosciuto persone straordinarie, persone che si rialzano tutti i giorni con l’unico obiettivo di cercare essere migliori di ieri, persone che lavorano e si sforzano di andare avanti in mezzo alla monotonia e alla povertà che caratterizzano la vita nel carcere.
Però, non tutto è di colore rosa. Ho incontrato anche tristezza, rabbia, ingiustizia, disperazione e sete di perdono per gli errori commessi in passato.
La pandemia fu, per noi del gruppo apostolico, una sfida e una opportunità di incontrare nuove forme per restare in contatto con questi nostri fratelli carcerati. Insomma, sono passati quasi 2 anni, nei quali non abbiamo potuto visitarli! Gli abbiamo mandato lettere, generi di prima necessità, dolci, messaggi, cartelloni, abbiamo recitato rosari virtuali pregando per la loro salute, e moltre altre iniziative. Gesù ci regalò la creatività per rimanere vicino a loro nonostante la forzata distanza.
L’anno scorso, in dicembre, ci informarono che finalmente avremmo potuto visitare il carcere. Non posso descrivere la gioia che provai. Fu una visita incredibile, nella quale ho potuto constatare che tutte le preghiere che avevamo offerto per loro avevano dato frutto. Ci ricevettero con gioia e soprattutto con una grande speranza di andare avanti nonostante la pandemia. Fu come reincontrare un vecchio amico.
A partire da gennaio, a causa dell’arrivo della variante Omicron, le visite al carcere furono sospese di nuovo. Pertanto, siamo stati molto incerti sulla possibilità di poter realizzare la tradizionale missione in carcere nella settimana santa. Ma con la benedizione di Dio, sì, ci siamo riusciti!
Questa Settimana Santa abbiamo avuto l’opportunità di visitare il carcere il Giovedì, il Venerdì e il Sabato Santo. Con l’aiuto di tutti i gruppi apostolici che visitano il carcere siamo riusciti a portare ai fratelli privati di libertà più di 1200 pacchi di generi di prima necessità, realizzare le celebrazioni liturgiche tipiche di ogni giorno, conversare, proporre attività e soprattutto portare loro un messaggio di speranza: ricordando che Gesù è vivo e che non si trattiene nel dare misericordia e amore in abbondanza.
Il mio cuore è ricolmo di amore perchè nuovamente sono riuscita a incontrare Gesù in carcere. Prego che continui a benedire tutti i gruppi che con molta allegria e dedizione visitano le carceri di tutto il mondo.
Oggi voglio invitare anche te a darti una opportunità di visitare il carcere! Sono necessari molti giovani come te e me, che trovino il coraggio di portare allegria e speranza alle persone private di libertà. Non temere! Ti prometto che non è come te lo immagini!
Ringrazio anche padre Stefano per il suo appoggio, dedizione e amore a questa missione che gli toccò realizzare. Preghiamo per le vocazioni sacerdotali!
Per concludere, mi piacerebbe lesciare questo messaggio: il carcere non è un luogo dimenticato da Dio, è un luogo che ha bisogno delle nostre preghiere e soprattutto della nostra fede. Fiducia in tutte le persone che lo abitano e che si sforzano di essere migliori per, un giorno, reintegrarsi nella società.
Grazie mille e un saluto dal Messico!
Tere Montzerrat Polanco Núñez – Merida
photo by https://unsplash.com/@grant_durr











