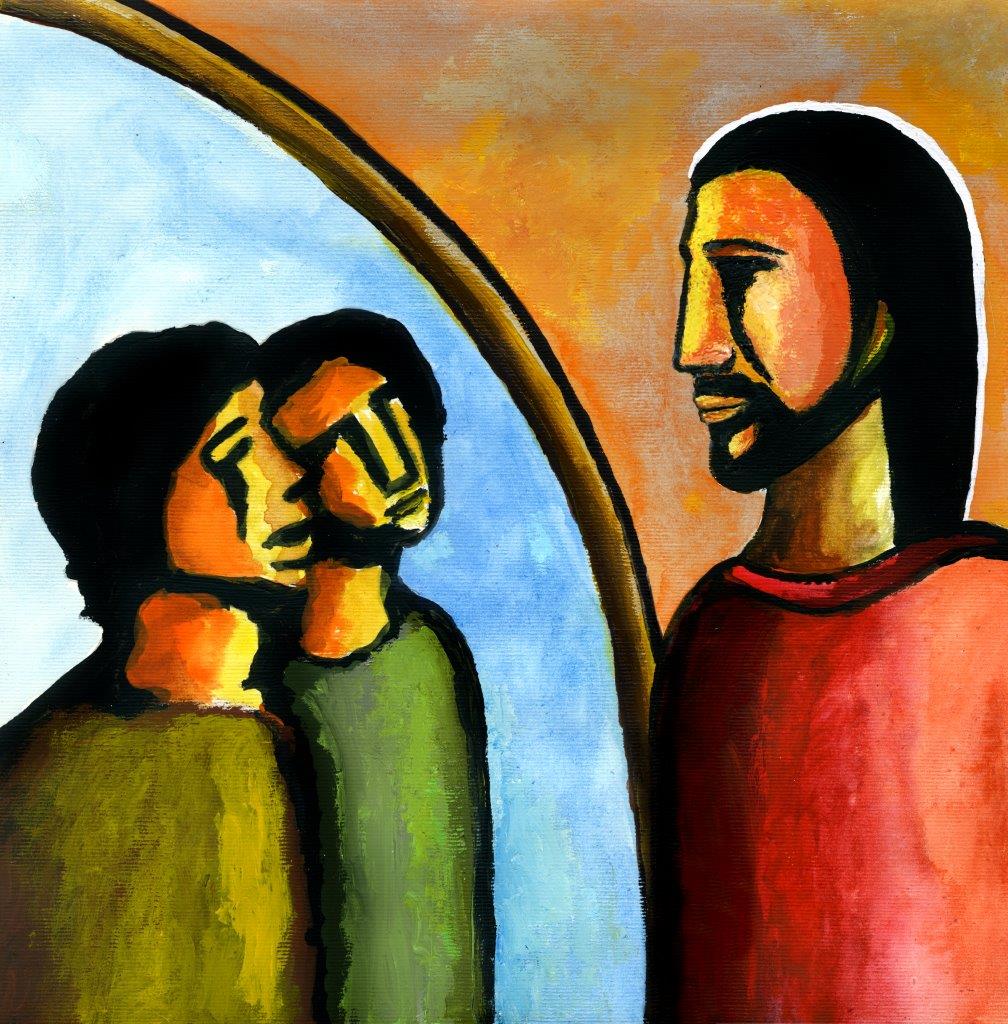C’è un grande scrivere e leggere su come pensare e ri-pensare la Chiesa oggi, in questa situazione di scristianizzazione e indifferenza verso la questione Dio, indifferenza che è più drammatica delle riflessioni ateistiche.
Tutte le analisi che la Chiesa pensante sta producendo in questi ultimi anni sono sicuramente stimolanti. Non che prima non pensasse e/o producesse, però ultimamente le riflessioni giocano sul fatto dell’indifferenza verso le cose di Dio.
Quando parlo con i giovani dico sempre loro che sono bravi, buoni e sanamente egoisti, ma non hanno più il senso del mistero o del sacro, quindi le loro doti restano doti e non diventano virtù. La scristianizzazione li tocca in prima persona. Se poi si cerca di riflettere su ciò l’impresa è più che ardua, forse impossibile. Usano un altro linguaggio. Ma la riflessione è difficile anche con gli adulti.
Come poter ripensare la fede, come poter superare (per usare la bella sintesi di papa Francesco) il si è sempre fatto così?
Se il giubileo di Paolo Vi e Giovanni Paolo II si sono aperti in tempi felici e stimolanti il germogliare di cose nuove, questo giubileo si apre in un mondo a pezzi: forse per questo la scelta della virtù della speranza come stella polare del pellegrinaggio giubilare.
Molti non hanno la consapevolezza del non dovere sempre fare così, molti ritengono che si debba continuare a fare sempre così, perché è più rassicurante, ma anche perché non è facile capire cosa si dovrebbe fare di nuovo.
L’evolversi della Tradizione nel passato è avvenuto in modo chiaro o lo si è scoperto solo dopo? Perché il problema oggi è proprio capire come far crescere la Tradizione. Uso coscientemente “crescere la Tradizione” perché sappiamo che la Tradizione è tale solo quando è capace di crescere, altrimenti muore.
I fedeli laici, ma non solo loro, possono anche leggere questo o quel documento, ma poi si fermano, perché non c’è la forza e il tempo di affrontare “il crescere della Tradizione”. Sanno che la maggior parte dei propri figli frequenta un mondo non cristiano, sanno che la maggior parte dei propri figli non frequenta la messa domenicale, sanno… ma non sanno come reagire.
La realtà che si deve affrontare, talvolta combattere, la realtà dalla quale si può trarre anche del bene è una realtà troppo grande e troppo disinteressata per i fondamentali della fede e quindi ci si ferma. Non in modo apatico o scoraggiato, semplicemente ci si ferma, forse come ci si fermò in Quel sabato santo.
Probabilmente dobbiamo imparare a vivere con maggiore cura il sabato santo della fede di oggi, se vogliamo che si possa risorgere con il Risorto.
San Giovanni Crisostomo scriveva: I magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella ma videro la stella perché si erano messi in cammino.
chiesa
FROCIAGGINE
Un anno fa Jonathan Bazzi scrisse dell’importanza di celebrare il Pride: chi si sente, chi è minoranza deve trovare il modo di farsi conoscere, non deve limitare il proprio orgoglio. Credo che la tesi di fondo sia condivisibile anche se dovrebbe valere per tutti, ma non tutte le minoranze hanno le medesime opportunità.
Ci sono dei diritti che certo vanno riconosciuti e non ledono il buon andamento di una società, anche dal punto di vista educativo, ma ci sono anche dei doveri o altri punti di vista che non per forza sono negativi o preclusivi, semplicemente fanno parte di una normale dialettica: trovare la quadra non è facile e indolore.
Qualche settimana fa il maggior rappresentante della chiesa cattolica ha usato un termine che ha lasciato tutti molto perplessi: “frociaggine”.
Questo termine ai vari pride di questo mese è stato usato, strausato, abusato. È un diritto del mondo gay o dei suoi sostenitori? Può darsi. Certamente molti si sono giustamente sentiti toccati e offesi.
Come credente tutto ciò mi ha fatto molto male, lo confesso pur cercando di comprenderne le cause. Quando ami qualche cosa, in questo caso la Chiesa, non puoi non soffrire. Mi fanno soffrire anche quanti da parte opposta (forse avversa), nella Chiesa cosiddetta custode della verità, trdizionalista, usano gli stessi metodi con obiettivi e intenzioni diversi.
In Italia “frocio” è sicuramente una parola offensiva che non è bello sentirsi dire, che non è bello gettare addosso a un altro o altra perché ferisce.
Che il papa l’abbia usata e riutilizzata qualche giorno dopo con tutta la consapevolezza del caso non saprei dirlo. È stata usata. Per denunciare una situazione? Per avvertire che bisogna avere maggiore e migliore attenzione alla dimensione identitaria e sessuale dei candidati al sacerdozio? Nella mia vita di seminarista e di prete poi non mi è capitato di trovarmi in un ambiente sessualmente e identitariamente depravato. Non sono mancati dei casi di persone allontanate perché incapaci, meglio senza la volontà di voler fare chiarezza su stessi o perché attenti in modo scorretto verso minori. Questo non significa che ci sia stata una attenta o giusta riflessione sulla sessualità, per molti versi si è un po’ arrancati.
Confesso senza vergogna che mi sono fatto delle domande sulla mia identità, anche sull’avere scelto il seminario per “scappare” da me stesso in modo decoroso! Se poi pensate che non ho mai giocato a calcio, che non ho mai amato la violenza o ho ricevuto alcuni due di picche… Quanti pensieri in un ventenne appena finito il servizio di leva militare potevano frullare nella testa! Con chi parlare di tutto ciò? Poi lo Spirito santo mi ha guidato come lui solo sa fare.
Parlare di ricerca e riconoscimento di identità non è facile nemmeno oggi, me ne accorgo con le decine e decine di ragazzi/e e giovani che incontro ormai da decenni. Affrontare con cura questo argomento è ancora faticoso e non solo per la Chiesa, ma per la società tutta, nonostante tutti i “via libera” di oggi. Forse perché la sessualità è comunque il nucleo più sacro e vulnerabile di ogni essere umano e anche della società. Non è tabù, è la fatica della ricerca di se stessi.
Non voglio ora entrare nella questione se una persona omosessuale possa o no essere ammessa in un seminario, questione che credo sia abbastanza chiara nelle indicazioni ufficiali della Chiesa, giuste o sbagliate che siano. Piuttosto credo che forse il Papa con il termine “frociaggine” volesse e vuole intendere l’importanza di avere degli ambienti chiari e non ambigui, non in senso negativo verso le persone omosessuali, bensì verso tutti noi. È una parola sbagliata? Non sempre abbiamo le parole giuste e corrette per tutti e per tutto quindi probabilmente non si dovrebbero usare. Però talvolta non siamo capaci di fare meglio. E questo mi pare il pensiero anche di alcuni seri pensatori omosessuali cristiani che hanno commentato il il fatto. A queste persone devo veramente molta gratitudine per i loro toni seri, ben diversi da tanti estremisti cattolici o laicissimi. Toni seri e di amore verso la Chiesa e anche verso i suoi limiti che da un po’ di tempo non sentivo.
Forse tutti noi dovremmo recuperare un sano orgoglio di essere noi stessi consapevoli dei diritti e dei doveri di tutti noi, anche quando altri non capissero, cercando piuttosto di vivere la nostra fede e di viverla seriamente.
Giannicola M. Simone
SANTOCIELO
«Se qualcuno ci ascolta o no è secondario, ma mi sento meno solo quando prego.»
Dal 14 dicembre è nelle sale il nuovo film di Ficarra e Picone, Santocielo, diretto da Francesco Amato; già regista di 18 regali.
Personalmente, il loro cinema non mi ha quasi mai convinto a differenza di quando li vedo in televisione. Nonostante il trailer non mi abbia fatto suscitare nulla, ero curioso di vederlo perché in primis il duo comico ritornava a parlare di religione dopo Il primo Natale e di cose legate all’ambiente cattolico, ma anche perché la nuova pellicola verteva su un argomento tanto interessante quanto delicato: un uomo che resta incinto per uno sbaglio commesso dall’Angelo mandato dal Padre Eterno con lo scopo di far nascere un nuovo Messia. Come si può capire, la premessa è fantasiosa e surreale. Ero quindi curioso di vedere se la coppia riusciva nell’intento di far riflettere gli spettatori e la critica circa un tema difficile da trattare e molto facile da far sfuggire di mano se non si riesce ad amalgamare bene con la trama, la durata e il racconto che vuole essere pure comico.
Il primo tempo può risultare anche carino da guardare, nonostante non si fosse prestato subito a rispettare le mie attese. La trama è molto banale e anche certi passaggi nel film non sono da meno. Ci sono diversi difetti: troviamo Giovanni Storti nei panni di Dio, uno dei ruoli più funzionali del film, ma lo si vede soltanto pochi minuti in circa due ore di pellicola. Inoltre, la durata è troppo lunga perché le commedie simili a questa dovrebbero durare sui 90-100 minuti. È un film che tratta l’inversione dei sessi in modo molto leggero, confuso nei suoi intenti e poco incisivo con l’umorismo. Tutto sembra spento, anche le gag non sembrano divertenti e spesso forzate.
Nel secondo tempo invece troviamo problemi legati alla Bibbia che possono essere orientati verso una mancanza di coraggio nell’affrontare certe tematiche. Santocielo sembra voler parlare della Chiesa che, come nella realtà, non accetta l’unione tra due persone dello stesso stesso, figuriamoci doversi trovar di fronte ad un uomo che deve partorire suo figlio. Da questo pretesto sarebbero potute nascere cose interessanti e stimolanti che avrebbero portato il pubblico a ridere, ma anche e soprattutto a pensare e riflettere su ciò appena visto. Mi è sembrato che il film non volesse aprire alcune porte, bensì tenersi nella “safe zone”.
Si va verso un finale accomodante, per niente incisivo dove forzatamente regnano i buoni sentimenti, ma dove anche non si ha il coraggio di criticare nessuno. Tutto quello che potrebbe essere devastante viene trattato come una piccola notazione irrilevante, macchiettistico e caricaturale. Come, ad esempio, la storia d’amore parallela tra l’Angelo e la suora. Essa è esterna al tema del film, ma condotta con una banalità che lo spunto non avrebbe. Pensiamo infatti a come una suora si sentirebbe e cosa proverebbe qualora si dovesse mai innamorare di una persona. Probabilmente le susciterebbero pensieri lontani dal percorso che ha scelto per la sua vita, e quindi di star perdendo la propria fede.
In Santocielo però ci sono proprio in ballo questioni cristiani come l’aborto o la tendenza degli umani a invocare l’aiuto divino per questioni triviali o altre situazioni scherzose che solitamente il cinema cristiano non fa. Quindi anche qui, non si capisce molto bene il taglio che hanno voluto dare all’opera. Avrei preferito e mi sarebbe piaciuto vedere uno spettacolo che, tra una risata e l’altra, denunciasse anche l’aspetto più bigotto della Chiesa (che non significa essere anticlericali) circa le unioni omosessuali, in quanto, lo ripeto, avrebbe fatto riflettere su una piaga che coinvolge la Chiesa da anni.
Marco C. – Milano
Chiese vuote… di giovani?
Le chiese sono vuote, di giovani (ma non solo).
La colpa è della Chiesa che non parla più di Cristo bensì di sole cose mondane.
I giovani hanno bisogno di Cristo non di cose mondane.
Lasciamo le necessarie cose del mondo al mondo.
I giovani scansano le chiese perché la Chiesa vuole fare da maestra in tutto non sapendo più parlare di Cristo.
Queste sono alcune delle riflessioni che molti credenti fanno alla realtà ecclesiale attuale. In particolare provo a rispondere a Matteo Matzuzi che sabato 18 novembre scriveva su IlFoglio un testo dal titolo Ite Missa Est proprio su questo tema.
Certo, ognuno ha le sue competenze, i propri ambiti di azione, ma i vari ambiti oggi più di ieri sono così interconnessi tra loro e sollecitano delle risposte anche morali.
Già Paolo VI, che non è l’ultimo arrivato, diceva che il credente deve avere su una mano il Vangelo e sull’altra il giornale, perché il vangelo è fatto per il mondo e il cristiano deve conoscere il mondo. Il Vangelo è la lampada da porre in cima al monte perché illumini le città degli uomini. Per illuminare il mondo è necessario conoscerlo.
E poi Dio si è fatto uomo in Gesù non per hobby, bensì “per conoscere” la storia degli uomini, perché gli uomini conoscessero la sua storia.
Non si può dare una fede senza il mondo e viceversa. Forse per troppo tempo si è voluto lasciare il mondo fuori dalle porte delle chiese, come fosse qualcosa di solamente cattivo, maligno e si è persa la capacità di comunicare.
Il problema non è parlare di Cristo, bensì scalfire l’indifferenza all’incontro con la persona Cristo. Questo perché l’apatia, l’indifferenza e l’individualismo della nostra società ormai sono all’apice del ben vivere: se già chiedere di incontrare l’uomo è una sfida, chiedere di incontrare l’uomo Cristo lo è ancora di più.
Non si può non parlare del mondo, perché il mondo tutto è stato ricapitolato in Cristo, perché ogni più piccolo granellino di sabbia o filo d’erba trovano il loro senso in Cristo! Certo il rischio di confondere l’ecologia con l’escatologia è alto, ma sempre è stato così. La sfida è far capire che l’ecologia senza escatologia diventa ideologia.
Forse non tutti sanno che l’escatologia è la conoscenza e l’esperienza del Paradiso; è lasciarsi guidare dalla luce e della realtà del Paradiso per dare direzione, significato e sapore all’ecologia non solo dell’ambiente, ma di ognuno di noi. Si può vivere la storia con tutte le ottime intenzioni ma solo nel presente. Si può vivere la storia con la prospettiva futura che dona continuamente speranza e forza nel presente.
Le chiese sono vuote non perché la Chiesa parla troppo del mondo e poco Cristo, bensì perché non ha ancora ritrovato quella capacità di parlare del mondo come segno della rivelazione di Cristo aperto alla luce di Cristo.
D’altra parte non è proprio il Concilio Vaticano II a scrivere: le gioie e le speranze, i dolori e le angosce degli uomini di oggi sono anche le gioie, le speranze, i dolori e le angosce dei discepoli di Cristo?
«Non so, mi scrive F., se dire le cose del mondo porti a oscurare Gesù, anche perché la religione insegna valori umani assolutamente condivisibili: fratellanza, rispetto… Quindi per forza bisogna trattare le interazioni umane che, diciamo, sono una manifestazione più diretta e visibile della Rivelazione».
Le fatiche del femminismo cristiano
Gli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo furono anni di grande cambiamento e fermento, in cui movimenti culturali e femministi iniziarono a reclamare a gran voce il riconoscimento dei diritti per le donne.
Oltre ai noti movimenti suffragisti inglesi e americani, ne esistevano diversi anche in Italia, portati avanti da studiose, filosofe e giornaliste. In molti casi, si trattò di associazioni definite di “femminismo cristiano”: le affiliate, infatti, aspiravano ad unire temi di denuncia sociale a principi e valori di ispirazione evangelica.
Tra le madri fondatrici di tali movimenti, vi fu Adelaide Coari, maestra cattolica che proponeva la costruzione di un programma minimo femminista, sulla scia delle rivendicazioni Socialiste di inizio secolo.
Tra le figure più importanti troviamo Elisa Salerno. Nata e vissuta a Vicenza, si interessò in particolare allo studio e alla denuncia delle condizioni operaie delle lavoratrici e dei lavoratori veneti. Formatasi da autodidatta, imparando il latino, il francese e il tedesco, la filosofia e la teologia, impiegò tali conoscenze per fondare, all’inizio del ‘900, il suo giornale dal titolo “La donna e il Lavoro”.
All’interno dell’editoriale, l’attenzione è posta in particolare su studi, ricerche e interviste alle donne della classe operaia vicentina, mettendo in luce, nel dettaglio, aspetti quali il divario salariale fra uomini e donne, le precarie e insalubri condizioni di lavoro, le continue sopraffazioni morali e sessuali a cui venivano sottoposte. L’idea di fondo di tale ricerca era che, oltre alla giusta battaglia sindacale e sociale, fosse soprattutto necessario una battaglia culturale e ideale, che partisse dall’istruzione, nel tentativo di avviare un radicale cambiamento ideologico.
In tale contesto, Salerno accusò pubblicamente la Chiesa e le sue istituzioni, che nonostante professassero la necessità di difendere e proteggere i deboli e gli ultimi, di fatto perpetravano la situazione di subalternità delle donne, a causa di un intrinseco antifemminismo nella patristica e nella scolastica.
Per tali coraggiose affermazioni, la studiosa fu prima condannata dalla Chiesa Locale, poi dalle Curia Romana e infine fu scomunicata, nel 1927, anno in cui interruppe definitivamente la sua produzione editoriale.
Giulia C. – Firenze
Blanco, un cantante a san Pietro
Lunedì 18 aprile, prima della Veglia con il pontefice, piazza San Pietro è stata il centro di un grande momento di festa. Dopo due anni di pandemia, don Michele Falabretti (responsabile dell’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale giovanile) ha organizzato un concerto prima del momento di preghiera per il Lunedì dell’Angelo. L’evento, avvenuto in concomitanza con il forte pellegrinaggio dei laici, ha riscosso moltissimo successo sul pubblico giovanile (circa 57000), ma anche in quello adulto. I ragazzi sono stati accompagnati di fatto da numerosi adulti, per lo più educatori, sacerdoti, volontari e famigliari. Inoltre, successivamente all’annuncio che le udienze generali riprenderanno a tenersi nella Piazza, il concerto è segno di un ritorno alla normalità che manca ormai da troppi anni. Averlo organizzato in periodo pasquale è un modo per incoraggiare le persone a credere in Gesù; metaforicamente si può vedere in esso una nuova rinascita proprio come quella che Gesù ha mostrato ai credenti “vincendo le tenebre della morte” riprendendo il Papa.
Per l’occasione, è stato invitato Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2022 nonché rappresentante, insieme a Mahmood, dell’Italia agli Eurovision Song Contest di Torino (martedì 10 e sabato 14 maggio. Aver scelto un volto noto come Blanco (oltre a lui erano presenti anche Giovanni Scifoni, Michele la Ginestra e Matteo Romano) è indubbiamente una mossa di apertura verso i più giovani che sempre più spesso si fanno condizionare dai grandi abbandonando gli oratori e i centri pastorali. Essendo Blanco la star del momento, scegliere una persona così significa anche da parte della Chiesa cercare di “riallacciare” i rapporti con un mondo giovanile sempre meno religioso e più ateo. Riccardo ha tatuato sul petto un angelo con una corona di spine, simbolo, spiegato dall’artista stesso che rappresenta la sua doppia natura: da una parte “bravo”, ma dall’altra “marcio”. L’angelo fa però intuire come la persona abbia avuto un’educazione religiosa e cristiana quindi avesse a che fare con l’evento organizzato dalla Chiesa. La sua esibizione è avvenuta in mondovisione, nel pomeriggio prima dell’arrivo di Papa Francesco. Tra i suoi brani ha portato Brividi, canzone vincitrice di Sanremo, e Blu Celeste, celebre canzone del suo omonimo album. Quest’ultima è un inno all’amore, l’arma più potente che l’uomo ha a disposizione. In questo caso, purtroppo è rivolto ad una persona che non c’è più e non ritorna.
“Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste”
In tutto il brano l’artista ha sensi di colpa, si sfoga, salvo poi autoassolversi; concetto che si presta all’idea di perdono cristiano. Possiamo quindi affermare quasi sicuramente che la scelta di far cantare Blanco non sia stata dovuta al momento che sta vivendo, ma anche all’abilità di scrittura, profonda e sensibile di Riccardo che in qualche modo, nonostante la giovane età, può essere d’esempio per milioni di persone.
Marco Ciniero, Milano
PREGIUDIZI SULLA CHIESA? brevi annotazioni sulla necessità di generare il futuro.
«Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dètte la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla?».
F. Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 125
Nell’atrio di questo millennio, che l’Occidente si appresta a vivere, che cos’è, cosa può essere e soprattutto cosa non potrà più essere deputata a fare, l’istituzione ecclesiastica, “baluardo” del nostro Vecchio Continente?
Non è importante, in questa sede, dibattere sui classici – e seduttivi – argomenti concernenti l’esistenza o l’inesistenza di Dio, il significato dell’esser fedeli, i meriti e i demeriti storici della cristianità e così via. Il punto essenziale, il crocevia, è il seguente: la Chiesa, il Vaticano, come si percepisce nel nostro tempo? Ora che siamo distanti ormai vent’anni dal secolo scorso, in che modo il mondo cattolico e mutato e quanto, ancora, muterà? Gli europei, come i cattolici, per fortuna o purtroppo, non possono ignorare determinati quesiti. Il motivo di ciò? Non esisterebbe l’Europa – la nostra, amata, Europa – se non esistesse il cristianesimo e viceversa. Sulla base di questo dato imprescindibile – il quale potrà essere confermato da chiunque si sia occupato, nel corso della sua esistenza, di discipline storiche, filosofiche e teologiche – non possiamo continuare a fingere di non vedere e non capire.
Al di là di quanto i governi e i cittadini europei ne possano dire, è impossibile non far caso alla forte crisi politica, culturale e antropologica, che tutti noi stiamo vivendo. Questo senso di disincanto, disorientamento e disillusione, ovviamente non può che coinvolgere anche la Chiesa alla quale, però, bisogna riconoscere che è da ormai un decennio che sta tentando disperatamente di restare aggrappata a un mondo che nessuno – veramente nessuno – riesce più a comprendere. Tuttavia, anche il mondo cattolico sta pagando a caro prezzo la vertigine della trasformazione antropologica che l’intero pianeta sta attraversando.
L’Occidente, dopo il 1989, ha dato progressivamente l’impressione di aver smarrito la bussola: crisi delle cosiddette socialdemocrazie, dissoluzione e disincanto nei confronti di qualsivoglia ideologia politica e ridimensionamento brutale del potere ecclesiastico. Tutto ciò, innegabilmente, ha incrementato il senso di smarrimento in tutti coloro i quali sono venuti al mondo a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio. L’opinione pubblica e gli organi d’informazione cercano le cause nella mancanza di occupazione che – a causa delle crisi economiche – avrebbe obliato nelle menti dei giovani l’idea di uno stralcio d’avvenire. Questo, in parte e solo in piccola parte, è vero. Bisogna considerare, però, che ci troviamo dinanzi a un cane che si morde la coda. Bene, la causa dei nostri mali va cercata proprio nell’assenza di luoghi dove cercare ristoro.
Tralasciando la questione politico-antropologica, vorrei concentrarmi sulla figura e sul luogo che può rappresentare la Chiesa. Non importa se Dio esiste o meno, ciò che conta è la domanda che un individuo nell’oggi può porre a Dio. Ogni tipo d’interesse, ogni forma di desiderio, amore e ammirazione, non è nient’altro che la formulazione di un quesito. Il fatto che qualcuno abbia assistito al collasso di un qualche tipo di ideologia politica certifica un fatto: quell’ideologia non era più in grado di rispondere, e forse neppure di accogliere, la domanda dell’interlocutore. Quest’ultimo, allo stesso tempo, ha rinunciato persino a formulare il quesito: “ma tutto ciò, alla fine, che senso ha? Meglio lasciar perdere. Che vada tutto in malora”.
Nei confronti della cristianità, dal mio punto di vista, è andata più o meno allo stesso modo. L’istituzione ecclesiastica, nella percezione comune, non è più in grado di rispondere ai più svariati quesiti. Tutto questo, però, è un dramma.
Una volta che abbiamo obliato il tutto – e, quindi, niente più ideologie, niente più Dio né religione – cosa ci resta? Che cosa siamo? Temo che ci resti il nulla e che, conseguentemente, non possiamo che scoprire d’esser divenuti un grande – seducente e amabile – niente.
La Chiesa accusa i giovani di non avere valori, mentre i giovani, al contrario, accusano il mondo cattolico di essere afflitto da un sistema valoriale anacronistico: un cane che si morde la coda, ripeto! Comunque, questa condizione, fa male indistintamente a tutti. Bisogna tentare necessariamente di distruggere entrambi i pregiudizi: le giovani generazioni devo smetterla d’immaginare la figura del cristiano come una figura fuori dal tempo e dal mondo; i cristiani, i sacerdoti, non devono dare più modo ai giovani di pensarli come obsoleti. Aprirsi al dialogo, alla diversità, alla differenza, aprirsi persino allo scontro. Essere disposti ad accettare le contraddizioni e le incoerenze. Solo attraverso una forma di caos produttivo, oggi, potrà germogliare una nuova idea di mondo, di casa, di futuro. Offrire l’avvenire, un pensiero, un paradiso che sia qui –nei corpi e nelle menti- e non solo in cielo!
La cristianità, del resto, dispone di armi potentissime – quali l’arte e la bellezza – per rigenerarsi. Il compito, oggi, spetta a tutti i seminaristi, a tutti coloro che si apprestano a divenire sacerdoti, ma anche ai cristiani giovani, sono loro il futuro della cristianità e solo formando in modo impeccabile i nuovi apostoli di Dio, Dio stesso riuscirà a non morire. I nuovi cattolici, i futuri signori di Dio, hanno il dovere di pensarsi come i “custodi del divenire”, affinché il nulla – che un tempo fu immaginato dalla Chiesa nelle vesti del Diavolo – possa finalmente cessare di tediare le nostre primavere.
Giuseppe P. – Aversa
Perché ancora non lascio la Chiesa
La domanda che mi hai posto è un po’ difficile e non credo di avere una risposta, perché è la stessa domanda che mi pongo anche io da 2 anni a questa parte: «Perché se critico così tanto la Chiesa non mi stacco?». Forse perché credo che la Chiesa come istituzione e la Chiesa che vivo io nella mia quotidianità siano in qualche modo diverse. Ho avuto la fortuna o possibilità di crescere in un oratorio e conoscere tanti padri con i quali si riesce a parlare, a confrontarsi, ad arricchirsi, in cui ognuno riesce ad esprimere il suo punto di vista senza sentirsi giudicato o attaccato. Forse questo è dovuto anche all’amicizia che si crea tra animatore e sacerdote per cui è più facile dialogare. In oratorio inoltre ho sempre avuto modo di confrontarmi con miei coetanei che bene o male affrontano i miei stessi dubbi, i miei stessi problemi: sentirsi in qualche modo supportato è sempre di aiuto. Ovviamente poi ci sono anche i preti barnabiti con cui non c’è proprio modo di dialogare né di far capire il proprio punto di vista perché sono completamente disinteressati nel cercare di comprendere il mondo dei giovani. È qui che mi altero e mi sento lontana dal mondo della Chiesa, una Chiesa che mi sembra sempre predicare bene ma razzolare male! Una Chiesa che troppo spesso esprime giudizi cattivi, che crea muri al posto di ponti, una chiesa che chiude porte quando sul Vangelo c’è scritto che tutti possono avvicinarsi a Gesù. Ovviamente questo mio discorso non è riferito a Papa Francesco, che ha fatto tanti passi avanti, ma ai tanti discorsi di sacerdoti che a volte mi capita di incontrare in autobus o delle suore oppure gli articoli che si leggono sul giornale o sui social. Ultimamente mi è capitato di leggere un articolo in cui un ragazzo sosteneva di essere guarito dall’omosessualità grazie a Dio, come se quest’ultima fosse una malattia. Sono queste le cose che mi lasciano senza parole. Un altro motivo per cui continuo a stare nella Chiesa forse è perché ho sempre distinto fede e Chiesa. Un conto è la mia fede, leggere la Bibbia, credere nella parola di Dio; un conto è la Chiesa che secondo me quello che fa è interpretare la Bibbia e darne una sua visione che può essere condivisibile o meno. Ma sicuramente il motivo che mi fa rimanere vicina all’oratorio di Roma è che quel posto mi ha dato tanto, tante esperienze che mi porto ancora dentro, tanti insegnamenti e mi ha sempre fatto vedere il mondo anche da altre prospettive meno egocentriche e materiali. LA cosa bella è che sto cercando di trasmettere tutto ai bambini che accompagno ai sacramenti: andare oltre a questo mondo troppo attaccato alle cose materiali e di ritrovare la bellezza nei piccoli gesti che uno può fare ogni giorno. Più o meno è questo quello che penso, che vivo, che amo e qualche volta dispero della Chiesa. Martina Chiesa, Roma
“Giovani distratti? Adulti, gli insegnanti!”. Intervista a P. Lello Lanzilli membro del Sinodo Giovani
Sinodo Giovani, Cari amici di Giovani Barnabiti, una nuova tappa del nostro cammino di riflessione sul Sinodo Giovani, che inizierà oggi mercoledì 3 ottobre 2018 qui a Roma, dove ci troviamo adesso insieme a padre Lello Lanzilli, gesuita, che fa parte del equipe di organizzazione ai livelli più alti del Sinodo, “I giovani la fede e il discernimento vocazionale”; gentilmente ci concede un po’ di tempo per ragionare insieme su questa bella opportunità che la Chiesa sta giocando come sfida nell’ incontro con voi giovani. Qualche domanda, quasi una chiacchierata amichevole, per entrare un po’ di più in questa macchina così importante e anche su qualche riflessione in risposta a domande da voi poste.
CLICCA ⇒QUI ⇐ PER ASCOLTARE L’INTERVISTA INTEGRALE
Il Sinodo è l’assemblea primaria dei vescovi del mondo voluta da Paolo VI per aiutare il papa a riflettere sui temi importanti e talvolta difficili della Chiesa, dei cristiani, prima di tutto cosa significa il titolo del Sinodo, “I giovani la fede e il discernimento vocazionale”?
Il Sinodo che è dedicato ai giovani ha l’intenzione di concentrare l’attenzione di tutta la Chiesa sulla realtà giovanile, su questa età della vita in cui tutti siamo chiamati e siamo impegnati a prendere delle decisioni importanti, sia per quanto riguarda lo stato di vita, sia per quanto riguarda le scelte professionali, sia per l’inserimento nella società. Per questo i giovani sono al centro dell’attenzione della Chiesa, ma non come soggetti passivi come se la Chiesa si interessasse a loro con un atteggiamento di tipo statistico o sociologico, sono al centro della vita della Chiesa, perché la Chiesa desidera che siano sempre più protagonisti. E quindi il tema della Fede è il tema della possibilità che loro hanno di esprimere la relazione che hanno con il trascendente, la relazione che hanno quelli che sono cristiani cattolici con Nostro Signore Gesù Cristo. E poi il discernimento vocazionale, e bisogna dire che il discernimento è un tema che i giovani nella riunione pre sinodale hanno faticato a comprendere, nessuno o quasi sapeva con precisione cosa significasse la parola discernimento, ma è semplicemente il discernimento e l’opportunità che viene data affinché i giovani possano scoprire qual è la loro vocazione, cioè qual è il loro posto nel mondo, nella società e nella vita, e farlo non in maniera superficiale ma a seguito da una riflessione alla luce dello Spirito che orienti la loro comprensione della loro vita e del loro posto nella società.
Il Papa ha invitato i giovani, credenti cristiani e non, non credenti per un dialogo in cui riuscire a sbriciolare un po’, per far comprendere meglio l’importanza di questa parola “discernimento”, ma anche l’importanza della parola “vocazione”: credo che sia un impegno molto importante. Come hanno accolto i giovani la sfida di questa parola magari poco usata nella loro quotidianità?
Mi riferisco soprattutto ai 300 giovani della riunione pre-sinodale, dal 19 al 24 marzo, convocati qui a Roma da tutto il mondo e dai vari ambiti della società, ma anche provenienti dall’esperienza di droga o carcere, poi giovani sportivi e giovani vittima di tratta perché proprio in questo Sinodo il Papa desidera che nessun giovane si senta escluso dall’attenzione e sollecitudine della Chiesa e dalla possibilità di partecipare attraverso le diverse forme che abbiamo individuato, come il questionario online, per esempio, di partecipare a questo momento di vita della chiesa cattolica. Alla riunione pre-sinodale oltre 300 giovani hanno partecipato anche 15.000 giovani, tutti hanno contribuito alla stesura del documento finale. A Roma erano presenti anche 5 o 6 non credenti; 7 giovani di altre confessioni cristiane; anche questi, sebbene il termine discernimento non facesse parte del loro vocabolario, hanno compreso l’importanza di fermarsi a riflettere in maniera seria e approfondita e alla luce di un criterio di alcuni criteri, un metodo, a riflettere su quello che è la loro vita e la possibilità di scelta e di progetti seri perché la propria vita abbia un senso, perché la propria vita possa sentirsi una vita realizzata non nel senso di potere raggiungere gli apici del successo, ma di potere raggiungere la gioia e la felicità, perché in fondo quello che è in linea con i sinodi precedenti, ma un po’ con tutto il magistero del Papa, quello che è importante è che i giovani capiscano che c’è una via per la gioia, che c’è una via per la felicità, che c’è la gioia dell’amore, che c’è anche la gioia della scienza.
Parlare di gioia significa anche, credo, parlare di salvezza; effettivamente alla domanda quale è la salvezza che ti aspetti molti si sono sentiti con le spalle al muro. La cercano in modi diversi.Nel suo ultimo viaggio nei Paesi Baltici Papa Francesco denunciava la disaffezione dei giovani per la Chiesa, a causa degli scandali della chiesa o della troppa commistione con il potere. Chiedeva alla Chiesa di riprendere ad ascoltare i giovani. Secondo te sarà facile o difficile ascoltare i giovani, specialmente tenere conto delle loro parole, delle loro denunce che purtroppo sono reali? Quando li incontri hanno una tensione verso la Chiesa ma sono preoccupati o allontanati da queste situazioni, se pur riconoscono che non è solo questo la Chiesa.
Tutto il percorso sinodale durato 2 anni, dall’ annuncio il 6 ottobre 2016, fino ad arrivare all’assemblea generale che comincerà il 3 ottobre 2018, fino alla stesura delle linee guida per la discussione, è stato un percorso di ascolto dei giovani in varie forme. Attraverso le conferenze episcopali (maniera classica), le associazioni o il web; tutti hanno ricevuto un documento preparatorio con annesso 15 domande generali e 3 per ogni continente. Anche questa è una particolarità, una novità di questo Sinodo. Sappiamo benissimo che la realtà giovanile, pur avendo diversi tratti in comune, ha anche delle differenze enormi, diversa è la società in cui vivono i giovani che sono stati oggetto di attacchi dell’ Isis per esempio e vivono situazioni di guerra, di tratta. Diverse dalle situazioni dei giovani che vivono nelle società occidentali dove i bisogni primari sono stati soddisfatti e magari c’è più un senso di insoddisfazione diffusa, di noia rispetto alla vita. Quindi i giovani sono stati protagonisti della prima fase del Sinodo, con l’ascolto diretto della riunione pre-sinodale e del documento finale; con il seminario di studi nel settembre 2017, con 50 esperti a livello mondiale più una ventina di giovani; con il questionario online che conteneva delle domande diverse rispetto a quello mandato ai Vescovi, domande più specifiche alla realtà dei giovani. Uscirà il report tra non molto, del questionario online, e ci sono delle sfumature particolarmente interessanti. Sono arrivati più di tremila contributi di singoli giovani. Mi sono commosso leggendo questi contributi, mi sono commosso per il loro desiderio di vivere una vita piena di senso, per la loro difficoltà a farlo e il sentirsi prigionieri in una società e un mondo che non promuovono le cose più belle dentro di loro. Le loro solitudine e difficoltà di vivere con un mondo di adulti, che continua a rimproverarli ma non vuole lasciargli le chiavi di casa sebbene ci dia degli esempi che sono pessimi e sono scandalosi. Noi parliamo spesso dei problemi dei giovani. Credo che il problema fondamentale siano gli adulti, non sono i giovani. Gli adulti che non sono stati in grado di indicare ciò che veramente vale nella vita. E continuano ad andare dietro a quelle cose. Rimproverano i giovani: sono distratti, stanno al cellulare, pensano solo alla palestra, ma questo l’hanno imparato dagli adulti. Genitori che prima di pensare alla possibilità di educare davvero i propri figli in molti casi hanno pensato al proprio autoreferenziale modo di vivere.
Passiamo ora a un altro aspetto più vicino a noi in Europa e Italia. Alcuni nostri giovani brasiliani e messicani mi dicono che forse questo Sinodo riguarda più l’Europa, l’Occidente, la sua ormai poca fede che il resto del mondo. Cosa ne pensi?
Si ci può essere questo rischio, però devo dire che c’è stata un’attenzione da parte di tutti ad allargare gli orizzonti, per esempio le domande specifiche per ogni Continente. Nella riunione pre-sinodale personalmente ho avuto l’impressione che la vitalità della chiesa è sicuramente nei continenti come l’Asia, l’Africa e l’America Latina. Piccolo esempio. Alla riunione abbiamo invitato i giovani per un momento di festa. Ognuno a seconda dei propri Continenti hanno presentato dei numeri, degli spettacoli. Hanno iniziato gli africani, molto bello e coinvolgente; hanno continuato gli asiatici con un loro stile più compassato, ma con humor molto sottile; poi il Medio Oriente, con canti molto armonici; l’America Latina ha concluso tutto con un trenino. Gli unici continenti che non hanno presentato nulla sono America del Nord ed Europa. Sicuramente la vita della Chiesa deve guardare sempre di più a questi continenti dove anche i numeri dicono che la realtà ecclesiale sta crescendo e dove c’è, in molti casi, un desiderio di accogliere la proposta di vita nuova, quale quella del Vangelo, che, a volte, nel mondo occidentale, sembra essersi perso; dico sembra perché, probabilmente, quello che si è perso non è il gusto, il desiderio, il senso, ma la capacità di saperlo trasmettere, in una maniera che sia sensata.
Torniamo al discorso degli adulti; è un Sinodo dei giovani ma che dovrebbe essere molto seguito da parte di tutti gli adulti, anche nella vita della Chiesa. Non tocchiamo ora la questione della trasmissione della fede ai giovani, ma sono d’accordo che noi adulti dovremmo interrogarci e quindi capire in cosa siamo stati mancanti, non per accusarci ma per essere più coerenti e capaci di comprendere la Verità.
Io faccio sempre un esempio; alcuni anni fa, nei tempi della mia gioventù, della mia adolescenza, il modello di riferimento della pubblicità, della società, delle riviste, era la persona adulta; si sapeva che la persona realizzata, colui che aveva raggiunto la pienezza dell’essere uomo, era l’adulto, con alcune caratteristiche: un senso di responsabilità, una capacità di sapersi divertire ma senza fare male agli altri; se guardiamo oggi, il modello che viene proposto, anche per gli adulti, è l’adolescente, cioè, colui che cerca di divertirsi, si ubriaca, passa il tempo solamente per il proprio piacere, il proprio tornaconto, questo è il modello di riferimento; non ci siamo resi conto che, noi vogliamo che i giovani siano adulti, ma in realtà, stiamo costringendo gli adulti a essere adolescenti. Altro tema su cui si spalancherebbero diverse riflessioni.
Ancora due domande; come funzionerà esattamente il Sinodo?
Il Sinodo inizierà Mercoledì 3 Ottobre con una celebrazione eucaristica sul sagrato di San Pietro e poi già nel pomeriggio cominceranno i lavori.Il Sinodo prevede la partecipazione dei padri sinodali, 266, con diritto di voto; in più ci sono gli uditori, 35 giovani e 16 formatori, i quali possono intervenire, anche nei circoli minori, ma non hanno diritto di voto; in più ci sono gli esperiti, 23, che collaboreranno con i segretari speciali e il relatore generale, proprio per l’elaborazione del documento finale. Ci saranno delle congregazioni generali, cioè delle riunioni in assemblea di tutti i Vescovi, in cui ciascuno potrà prendere la parola su una delle tre parti in cui è diviso l’Instrumentum laboris; la prima parte è relativa alla condizione giovanile, la seconda parte al discernimento e alla vocazione e la terza relativa alla prassi, all’azione pastorale della Chiesa. Ogni vescovo potrà fare un intervento su una di queste parti, poi si svolgerà il lavoro nei circoli minori, cioè dei circoli linguistici (francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco)in cui verranno fatti degli emendamenti, delle proposte di cambiamento al testo dell’Instrumentum laboris, che sarà il testo base anche per l’elaborazione del documento finale. Quindi possono essere fatte proposte di cambiamento, di eliminazione di parti, di aggiunta di altre parti, di altre frasi e quindi, attraverso quelli che vengono chiamati “i modi”, si procederà all’elaborazione del documento finale che sarà compito del relatore generale insieme ai segretari speciali. Questo sinodo ha 2 segretari speciali e ad una commissione di membri eletti proprio a questo scopo.
Grazie perché sapere come funziona una macchina credo che sia importante. L’ultima domanda a Padre Lello che ha una grande esperienza sia missionaria (abbiamo condiviso momenti belli anche in Albania appena dopo il crollo della dittatura), sia formatrice e che ringrazio per questa disponibilità di tempo, l’ultima domanda: che cosa ti aspetti, che cosa desidereresti di più visto da questo sinodo che stai vivendo ancora di più dal suo interno?
Ma credo che il mio desiderio e la mia speranza sia un po’ quella di tutti ed il Papa l’ha già espresso, l’augurio che questo sinodo possa davvero contribuire al rinnovamento e al ringiovanimento della Chiesa, ringiovanimento nel senso forte del termine, non nel senso adolescenziale che dicevo prima, ma nella possibilità che la Chiesa riscopra quella carica di entusiasmo, quella apertura alla vita, quel desiderio di costruire qualcosa di importante che è propria dei giovani di oggi tempo che, come dicevamo forse, nella nostra società occidentale sta venendo un po’ meno e di rinnovamento nel senso che grazie anche ai giovani, alla loro parola, alla loro creatività e al loro entusiasmo un po’ tutta la vita della Chiesa possa riprendere slancio anche nelle sue strutture e nelle modalità di celebrazione. Ecco ringiovanimento e rinnovamento della Chiesa e tutto questo non limitato esclusivamente ad usum interno, diciamo, ma perché la Chiesa possa essere davvero un fermento di vita per tutta la società. Una delle esperienze forti della riunione pre-sinodale, al di là del documento finale che, secondo me, è molto bello e molto interessante, è stata esattamente la convivenza dei giovani cattolici con giovani non credenti, giovani di altre religioni, perché gli stessi cattolici si sono accorti che il loro modo di essere, il loro linguaggio era troppo da ghetto. Hanno detto che la presenza di altri qui insieme a loro ha costretto a ripensare e a riformulare la nostra fede in una maniera che sia comprensibile per il mondo di oggi; non solo come qualcosa da condividere tra di loro, quasi fosse un codice segreto, quasi fosse una setta. I giovani, hanno detto, hanno fatto un’esperienza di Chiesa così come la vorrebbero, una Chiesa davvero sinodale, una Chiesa che accoglie tutti, pur non negando le differenze che ci sono, che accoglie tutti e che davvero si preoccupa per il bene di tutti.
Bene, avremmo ancora forse altre domande, ma ci fermiamo qui e ringraziamo di cuore Padre Lello Lanzilli della Compagnia di Gesù che ci ha dedicato questo tempo per riflettere e sicuramente i suoi spunti cercheremo di svilupparli e di “sbriciolarli” un po’ di più nelle nostre realtà, per momenti di incontro e di crescita e, chissà, forse, ci rivedremo dopo il Sinodo per sentire se ha risposto anche più di quello che magari ci si aspettasse. Grazie ancora.
Grazie a voi e buona vita a tutti
( Hanno collaborato:
Massimiliano Serino, Andrea Pistelli, Margherita Pedron, Bianca Contardi e Bernardo Bonaccorsi – Firenze;
per la parte tecnica Giacomo Camilletti e p. Giannicola M. Simone – Roma)
Parlate a noi adulti
Di questo siamo tutti sicuri: il Sinodo dei Vescovi sui giovani è un evento storico, che rappresenta un avvicinamento della Chiesa a quel mondo dei giovani sempre percepito unicamente come destinatario degli insegnamenti, dell’istruzione e dei rimproveri degli adulti, specialmente quando il rapporto è Giovani – Chiesa. Con il Sinodo i giovani diventano attori, sono loro a parlare. Proprio questo è stato il suggerimento di Papa Francesco durante la riunione presinodale tenutasi a Roma dal 19 al 24 marzo e ce lo dice Gabriella Serra, Presidente Nazionale femminile della F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), che vi ha partecipato e che ci ha gentilmente concesso una breve intervista, per raccontarci quanto vissuto durante l’incontro, ma anche la percezione di cosa sta avvenendo, che ha come esito finale e tanto atteso proprio il Sinodo dei Vescovi sui giovani.
«Si sta vivendo un ottimo momento – dice Gabriella – nel quale i giovani vengono coinvolti veramente, in prima persona, attraverso una partecipazione attiva e concreta». Infatti, Papa Francesco, durante la riunione presinodale ha chiesto con forza ai giovani di “parlare” a gran voce avendo il coraggio di esprimersi e raccontarsi, perché la Chiesa ha più che mai bisogno di capire i giovani e per questo è necessario un dialogo aperto con essi.
Papa Francesco ha ricordato che tutti siamo parte della Chiesa, anche i giovani e, per questo, ognuno ne è responsabile, aggiungendo: «anche se noi adulti tacciamo, voi dovete parlare»; proprio da ciò, ci dice Gabriella: «Si intuisce quanto a Papa Francesco stia a cuore la causa; è proprio lui il grande promotore di questo Sinodo, nuovo nella forma di coinvolgimento. È lui che ci ha dato e continua a darci la forza, il coraggio e la speranza».
Ripercorrendo il documento finale della riunione presinodale, ci si accorge di quanto siano stati ridotti e assottigliati gli spazi che hanno da sempre separato la struttura fortemente gerarchizzata della Chiesa con il popolo giovanile. Papa Francesco ha parlato a tutti i giovani presenti in modo diretto, colloquiale, paritetico e la prova di ciò sta anche nella riuscita di quella che era una grande sfida: riunire tutti e 5 i continenti del monto durante questo evento a Roma, 300 ragazzi più molti altri collegati via web.
Dal Documento emerge anche un tema cruciale, specialmente in questo periodo, non solo per la Chiesa ma anche per la società: la donna. Si è ricordato quanto importante sia e debba essere il ruolo che la donna ricopre all’interno della società e della Chiesa, chiedendosi quale sia l’apporto che la donna può dare all’interno della società e della Chiesa.
Infine, «È stato dato spazio anche a un altro rilevante tema: il volontariato. Si è sottolineato come il volontariato sia un metodo adeguato per permettere ai giovani di sentirsi utili, responsabilizzati e coinvolti all’interno della società e della Chiesa. Un modo per sentirsi vicini al prossimo in modo attivo e concreto, corresponsabili del mondo che si abita e dei luoghi che si vivono», visto il riscontro di una recente problematica giovanile legata proprio a uno scoraggiamento generale per la scarsa responsabilità che si sentono di avere all’interno della società e, di conseguenza, maturano una percezione, spesso inconscia, di essere inutili.
Dalle parole di Gabriella si sente la grande soddisfazione di aver assistito e partecipato in prima persona all’evento, facendo trasparire una grande emozione e un grande entusiasmo, accompagnati da profonda consapevolezza, da lei sottolineata: l’importanza storica dell’evento.
Noi GiovaniBarnabiti ringraziamo Gabriella per l’esperienza vissuta e per averla raccontata e condivisa rendendoci partecipi, anche se indirettamente, delle emozioni vissute e dell’impegno profuso. Le auguriamo un grande “in bocca al lupo” per il futuro, sperando che le nostre strade possano incrociarsi ancora.
Tommaso C. Milano