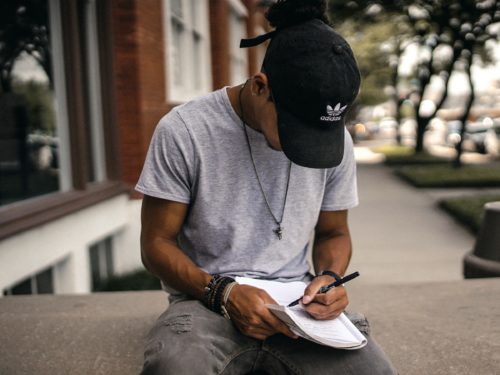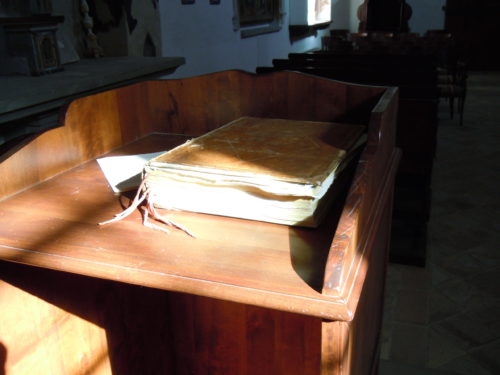Allora, innanzitutto la mia passione al ciclismo è iniziata grazie a mio padre che ha corso per molti anni ad alto livello. E inoltre perché per me la bici è una via di sfogo. Faccio ciclismo agonistico da poco più di un anno. Prima la bici per me era un divertimento mentre adesso è un impegno. Sicuramente 5/6 allenamenti alla settimana con gara la domenica si sentono, è un impegno che richiede sacrifici però io non ne sento il peso perché è un’attività che mi piace fare con passione. Sicuramente ciò che mi scoccia di più è non mangiare quello che voglio. Ovviamente ogni tanto posso fare uno strappo alla regola, però cerco di farlo il meno possibile perché io voglio essere forte nel mio sport e non lasciare nulla al caso.
Quando faccio fatica con i 200 bpm al minuto (battiti del cuore per minuto) non mi fermo, vado avanti e cerco di dare sempre il massimo per non avere rimpianti nel futuro.
Mentre mi alleno, sinceramente, non penso a tante cose. Cerco di restare il più concentrato possibile nel mio allenamento giornaliero. Sicuramente prima che iniziassi a fare questo sport a livello agonistico mentre uscivo in bici pensavo a di tutto un po’ senza stare attento all’allenamento ecc…
Speranze? Spero che un giorno tutti questi sacrifici siano ripagati magari da una vittoria in una gara perché, modestamente, me lo meriterei considerato l’impegno che sto dedicando a questo sport.
Se il ciclismo fosse una materia scolastica avrei 10 ne sono più che certo e se io mettessi l’impegno che metto nel ciclismo nella scuola avrei tutti 8!
Per finire voglio dire che il ciclismo è uno sport che richiede anche grande coraggio (ci vuole tanto coraggio per stare in gruppo a velocità elevate come 50kmh) e la paura va eliminata se no è meglio cambiare sport. Per esempio l’anno scorso mi sono rotto una costola per una brutta caduta a 60kmh in volata, ma più ripenso a quel momento e più sono determinato. Una cosa che mi ha insegnato il ciclismo è che quando si cade ci si rialza subito senza esitare. Subito dopo la caduta a 60kmh io mi sono alzato e ho finito la gara perché volevo finirla assolutamente.
Gregorio C., 3LES, SLuigi – Bologna