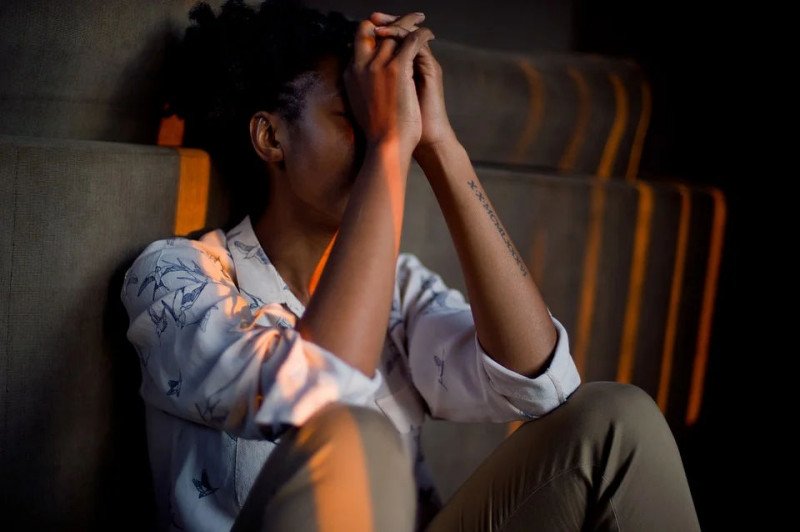Con este lema comienza oficialmente nuestra aventura junto a los padres Barnabitas de Mérida – Yucatán, México.
Con gusto publicamos las expectativas de cuatro de nuestros voluntarios entre los 9 que vivirán esta oportunidad:
Cuando cumples18 años, el verano representa la libertad, las salidas con los amigos, las primeras vacaciones juntos y yo también me imaginaba que pasaría mi verano así. Luego se me presentó un viaje a México, como voluntario, en una misión de los padres Barnabitas: ¡no tardé en cambiar de opinión! Al principio estaba muy indeciso porque significaba, y sigue significando, hacer solo el primer viaje al extranjero, pero las preocupaciones no se limitan a eso; los diferentes usos y costumbres pueden representar un obstáculo difícil de superar, y ni hablar del idioma -del que conozco pocas palabras-. Sin embargo, creo que todo esto es un “riesgo” que vale la pena correr, porque experiencias de este tipo, a mi edad, ocurren sólo una vez en la vida y espero que sean formativas tanto a nivel personal como en términos de interacción con los demás. También estoy convencido de que ver y poder tocar con mis propias manos las carencias y las dificultades de otras sociedades puede darme una apertura mental que hoy, en un mundo que tiende cada vez más al egoísmo y al bienestar personal, es una característica fundamental poseer Así que a la pregunta del Padre Giannicola “¿por qué elegiste embarcarte en esta aventura?” respondo: para poder mejorar, como persona y como joven, y, a mi manera pequeña, esperando poder dar una mano prestándome a todos los servicios necesarios.
Michele LaD. – Bolonia
En agosto del 2023, a pesar de mi corta edad, estaré a punto de vivir una experiencia destinada a marcarme para el resto de mi vida. La oportunidad de embarcarme en un viaje así siempre ha sido un sueño para mí. De hecho, desde niño, he tenido el compromiso de intentar ayudar a los demás, pero ninguna actividad de voluntariado en la que he participado se puede comparar con esta futura experiencia. Ir a un lugar tan lejano y culturalmente diferente será profundamente educativo, me ayudará a crecer y madurar. Será un viaje inolvidable, en el que mejoraré mi sentido de la empatía y en el que viviré de primera mano las dificultades a las que algunas personas están acostumbradas a vivir. Espero sinceramente poder contribuir a las comunidades que encontraremos, siendo conscientes de las dificultades que podemos encontrar. Finalmente seré capaz de ayudar realmente a alguien, yendo directamente a los lugares que necesitan. Probablemente, emprender un viaje así a los 18 años requiere un poco de valentía e inconsciencia, pero la posibilidad de ser realmente útil en mi vida es un impulso más fuerte que los miedos. En pocas palabras, en unos meses viviré lo que, desde chico, siempre he soñado, y la esperanza es estar a la altura de todo lo que se requerirá de mí.
Arturo M. – Bolonia
Siempre me han fascinado las experiencias de voluntariado, de aquellos que volaban al extranjero para dedicar su tiempo a ayudar a otras personas, a transmitir su cultura y tradición, o simplemente a entretener a los niños pero también a los adultos que cada día están en contacto con una realidad bastante diferente. y complicada comparado con la, pero igualmente fascinante. Este año también tendré la oportunidad de poder vivir una experiencia de este tipo, más precisamente una experiencia de voluntariado en México, en la ciudad de Mérida, con los Padres Barnabitas. Aunque es un camino largo, lleno de compromiso y sacrificio, no dudé ni un momento en confirmar mi presencia para sumarme al proyecto. En el momento en que me llegó la propuesta, sentí dentro de mí el sentido del deber que siempre he tenido con el voluntariado, comprendí que era hora de profundizar y ampliar mi camino, que partía del servicio prestado en el comedor de los pobres de la ciudad de Como, a un viaje al extranjero que me hubiera dejado una huella imborrable. Creo que el objetivo del viaje, junto con otros jóvenes, será diseñar y organizar actividades que puedan estimular a los niños especialmente a nivel social y en el campo del aprendizaje, a través de juegos, canciones y talleres al aire libre. De este viaje espero volver como una persona nueva pero sobre todo enriquecida: estoy segura que el espíritu genuino, especialmente de los niños, me llenará de alegría, haciéndome comprender que la alegría y la alegría de la niñez se encuentran también en las circunstancias más difíciles. Estos son mis propósitos de partir y emprender un viaje en el que pondré todo mi esfuerzo y fuerza, para dar mi aporte y marcar la diferencia en mi vida y la de algunas personas.
Lucrecia S. – Como
¡¡15 días en Mérida (México) participando en actividades de entretenimiento para niños del lugar, junto con un grupo de adolescentes italianos y otros jóvenes de las comunidades locales de los Padres Barnabitas!! Cuando pienso en este extraordinario viaje, me llena una gran emoción, porque sé que esta experiencia cambiará mi vida y dejará una huella imborrable en mi corazón. No puedo evitar pensar en todas esas sonrisas que veré y la energía contagiosa de las personas que conoceré a lo largo de mi viaje. Siento que me enriquecerán, mucho más de lo que yo podré hacer por ellos. Imagino las caras curiosas de los niños mientras comparto con ellos momentos de juego, creatividad y divertido. Me pregunto cuáles son sus historias, sueños y esperanzas. Tengo muchas ganas de sumergirme en su cultura, aprender de sus tradiciones y descubrir nuevas formas de ver el mundo a través de sus ojos. Al mismo tiempo, admito que hay cierta ansiedad que me acompaña, pero creo que es normal sentirme así cuando me aventuro en un territorio desconocido. Saber que tengo la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de estos niños me llena de gratitud. Quizás no todo sea fácil, pero tengo fe en mis habilidades y en el apoyo de los demás muchachos que me acompañarán en esta aventura. Mientras me preparo para ir, me concentro en lo que puedo ofrecer y cómo puedo ayudar a crear un impacto positivo. Estoy llena de ilusión y ganas de hacer especiales estos momentos, de compartir amor, alegría y sonrisas con todas las personas que encontraré en estas dos semanas. Así que, con la bolsa llena de ilusión y el corazón abierto, partí rumbo a Mérida, dispuesto a comenzar esta extraordinaria aventura. Espero dejar una impresión duradera y crear recuerdos que llevaré conmigo toda la vida.
Ricardo S. – Lodi