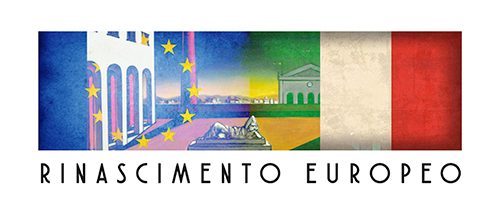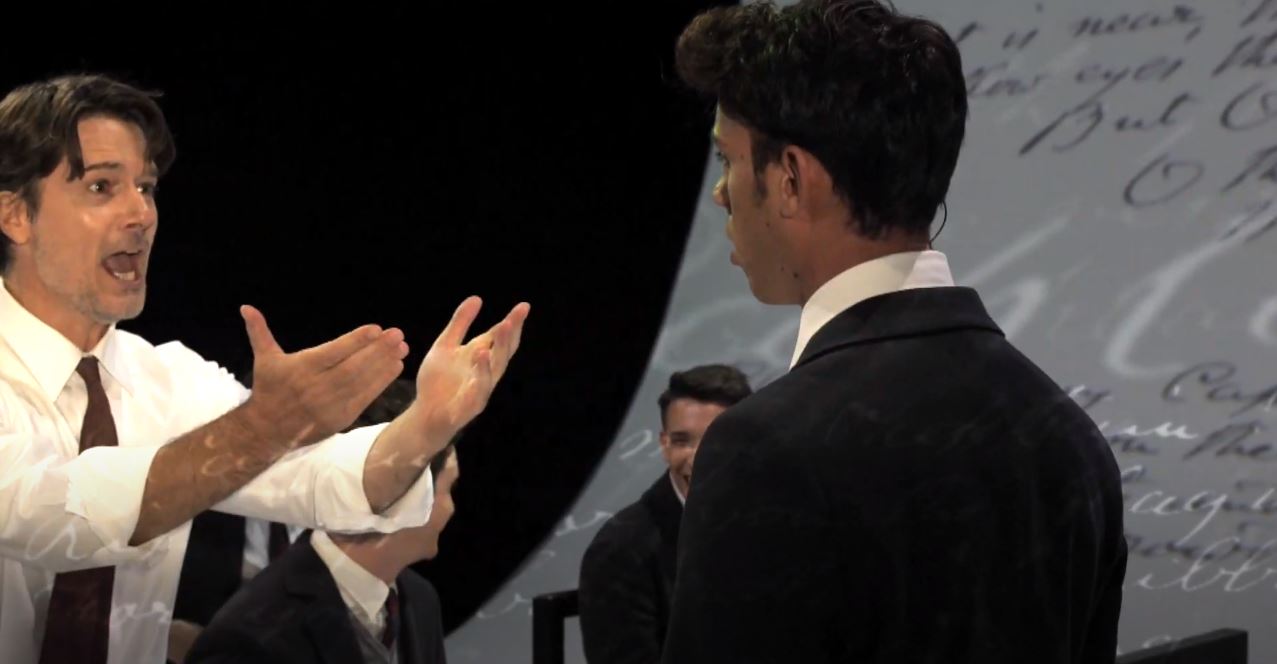Gli studi seguiti, il lavoro che svolgo e, perché no, questa collaborazione giornalistica, mi hanno portato a riflettere con più metodo su un tema molto delicato, che sta alla base di ogni comunità di persone: la pena come conseguenza di un comportamento considerato riprovevole dall’ordinamento. Sarà una riflessione complessa che richiederà qualche puntata e un po’ di spazio, per questo verrà pubblicata su IlGiovaniBarnabiti come estratto della pubblicazione totale sul blog.
In questo articolo parleremo di un tema molto delicato, che sta alla base di ogni comunità di persone: la pena come conseguenza di un comportamento considerato riprovevole dall’ordinamento.
Il modus con cui l’ordinamento punisce i rei mostra la condizione dell’individuo all’interno della società e di come questa risponda alle esigenze del vivere comune, comprensivo di tutte le caratteristiche umane, tra cui commettere delle azioni che ledano diritti fondamentali altrui, tutelati dal sistema penale.
I nostri giovani lettori potrebbero pensare che il carcere, la prigione, siano da sempre lo strumento che la società adopera per contenere chi commette dei reati, tuttavia così non è, o meglio, così non è sempre stato.
Oggi intendo fare una prima analisi di come l’umanità punisca le condotte pericolose dei suoi singoli, partendo da una breve premessa storica, per concentrarci successivamente sulla direzione futuribile.
Le prime testimonianze di prigioni o carceri si hanno nella Bibbia, nell’antichità, particolarmente nella cultura greco romana, in cui si utilizzavano delle gabbie per “contenere” gli uomini, in attesa di un verdetto che potesse portare in seguito alla pena vera e propria, di natura corporale o capitale.
Erano dunque il dolore o la morte a punire l’uomo, non la reclusione, che era solo uno strumento cautelare per garantire poi l’esecuzione.
Nelle epoche successive, durante il medioevo, si iniziò a teorizzare una visione cristiana della pena, in cui la reclusione del reo in prigione era considerazione di un’espiazione, in cui le azioni delittuose coincidevano con dei peccati, in modo tale il tempo passato in stato di privazione della libertà personale era del tutto propedeutico anche ad una salvezza dell’anima.
Fu dunque la dottrina cristiana a iniziare a ridurre le pene corporali o capitali, sostituendole per fatti di minore gravità con una detenzione, che compiva anche l’ovvio effetto di tenere distaccati i soggetti pericolosi dalla comunità, delimitando a casi gravi i tipici spargimenti di sangue conseguenti ai processi della storia.
Durante l’illuminismo, con la nascita di grandi intellettuali, anche giuristi e penalisti, si rivoluzionò il sistema giuridico e di conseguenza quello punitivo.
Il carcere diventò la vera e propria pena, poiché in seguito a dibattiti filosofici, politici e sociali, si giunse alla conclusione che non fosse più accettabile punire corporalmente o con la morte gli imputati considerati colpevoli.
Questo principio, all’inizio soltanto teorico, si strutturò nel tempo e riuscì a trovare la propria dimensione anche a livello ordinamentale e non più soltanto a livello filosofico, in età moderna e contemporanea, in cui la reclusione in carcere diventò la pena.
In età moderna si cercò anche di stabilire con limiti più precisi il funzionamento degli apparati carcerari e a salvaguardare i diritti dei detenuti, considerando una funzione nuova per la detenzione, che superava la vecchia concezione cristiana di espiazione, adducendo un nuovo principio laico e statale di risocializzazione del reo, soggetto che aveva commesso un reato, e che andava punito per poter essere successivamente reinserito nella società, con la ragionevole certezza che non commettesse più altri reati e che, anzi, diventasse un individuo utile.
Tale onorevole aspettativa, che tutt’oggi sussiste, è ciò che ci porta a riflettere su questo tema, se davvero la detenzione in carcere sia strumentale alla risocializzazione.
Nella società di oggi è dunque naturale chiederci quanto sia ancora necessaria la pena detentiva, alla luce di tante problematiche che il sistema penitenziario presenta, soprattutto in Italia, quali sovraffollamento, scarsa igiene generale e poca attenzione ai diritti essenziali dell’uomo detenuto.
Inoltre c’è un secondo aspetto da dover considerare, cioè se effettivamente privare della libertà una persona e metterla in contatto continuato con altri criminali, porti ad un esito positivo nella vita del detenuto e non ad una esclusione ancor più maggiore di questi, che molto spesso in seguito all’esecuzione di condanne diventa ancor più esperto di criminalità e una volta tornato in libertà spesso ricade nella commissione di altri reati, anche a fronte di un pregiudizio sociale e di un’ esclusione che questi subisce dalla comunità esterna, finendo in un circolo vizioso, che la realtà ci racconta essere presente in una maggioranza dei casi, di cui tantissimi casi di recidiva ci testimoniano la verità di quanto detto.
Nonostante ci siano anche episodi di successo rieducativo delle carceri italiani, con esempi di istituti in cui varie attività artigianali ed artistiche coinvolgono i detenuti, aiutandoli a risocializzarsi, la realtà precedentemente descritta è molto più spesso ciò che si verifica nella realtà.
La situazione paradossale è talmente evidente che lo stesso stato ha introdotto e attuato con generosità diverse misure alternative alla detenzione in carcere, quali gli arresti domiciliari, la libertà vigilata o i lavori socialmente utili, iniziando a snocciolare un problema molto complesso e che ad oggi non presenta ancora una vera e propria soluzione praticabile.
La cultura e l’intelligenza contemporanea è chiamata a valutare quale debba essere il nuovo piano di azione riguardo al sistema penale e penitenziario, perché le criticità appena accennate sono molte e complesse.
Sicuramente un primo importante impulso deve essere di ridurre a casi limite la pena detentiva, riguardo solamente a fattispecie che necessitino di tale estrema ratio, ad esempio per soggetti pericolosi socialmente o per reati violenti e gravi.
Le misure alternative alla detenzione devono essere il nuovo mezzo di risocializzazione, in particolare i lavori di pubblica utilità credo possano essere lo strumento giusto e migliore per garantire risocializzazione senza tralasciare la dignità umana, andando dunque verso una previsione più strutturata e meglio organizzata di tale istituto.
Un altro metodo punitivo e altrettanto deterrente è quello riguardante le sanzioni pecuniarie, per cui scontare la pena significa pagare somme, più o meno ingenti, di denaro in favore dello stato e a favore delle persone offese a titolo di risarcimento danni.
Anche questa situazione eleva la pena a dei principi più umani e più in linea con la filosofia e la sociologia contemporanea, poiché non degradante di diritti umani fondamentali.
Un’ulteriore possibilità potrebbe essere un controllo più serrato sui cittadini colpevoli attraverso i potentissimi mezzi tecnologici odierni, che verrebbero privati “soltanto” di una libertà di avere privacy, punizione pesante ma sicuramente meno invasiva e degradante rispetto ad una reclusione.
Oggi è importante iniziare a pensare e a parlare di questo tema, affinché si generi in tutta la società un input di riflessione riguardo a questo aspetto della vita comune.
Di particolare importanza e dunque meritevole di analisi e di miglioramento è per noi cristiani il tema dei diritti dell’uomo, di come questi diritti rimangano anche per gli uomini “erranti”, poiché agli occhi di Dio tutti lo siamo ma nessuno viene lasciato indietro.
Paolo Peviani – Pavia